 |
 |
 |
 |
1. Le organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani.
L'esperienza investigativa e giudiziaria, maturata soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni novanta, consente di ricostruire le caratteristiche fondamentali delle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico degli esseri umani verso il nostro Paese.
In questo nuovo mercato criminale, i sodalizi che vi operano si differenziano tra loro in base ad una serie di fattori, tra i quali: le dimensioni, la capacità di agire in uno ovvero contemporaneamente in più territori e in più mercati illeciti, la capacità di utilizzare una o più rotte clandestine e, infine, la capacità di fornire uno o più servizi illeciti specifici.
La struttura organizzativa complessiva che raggruppa i soggetti criminali operanti tanto nello smuggling quanto nel trafficking può essere definita come un sistema criminale integrato (29). Da un punto di vista descrittivo, infatti, delle organizzazioni criminali agenti nel traffico di persone, si può proporre una distinzione in tre distinti livelli, tenendo conto che tra di essi sussistono rapporti di interdipendenza e di complementarietà, mentre non sono stati ancora giudiziariamente riscontrati rapporti di tipo gerarchico. I tre distinti livelli sono i seguenti:
a) livello alto, in cui agiscono le cosiddette organizzazioni etniche (30) così definite in quanto pianificano e gestiscono lo spostamento dal paese di origine a quello di destinazione di loro connazionali.
Le organizzazioni criminali etniche gestiscono i flussi migratori illegali provenienti dall'Asia (es. Filippine, Cina), dal Sub-continente indiano (es. Bangladesh, Sri Lanka) e dall'Africa. Le persone vengono trasferite da un continente ad un altro non solo in virtù della stipulazione di un contratto illecito di trasporto (immigrazione clandestina), ma anche per essere successivamente sfruttate dal punto di vista sessuale, del lavoro forzato, della bassa manovalanza criminale e dell'accattonaggio (tratta).
In questo primo livello operano, inoltre, anche le organizzazioni criminali mafiose dell'Est europeo, principalmente dedite alla tratta
delle giovani donne da inserire successivamente nel mercato della prostituzione, sia la mafia turca dedita principalmente all'immigrazione clandestina curda.
Le organizzazioni etniche non partecipano né alla fase del trasporto dei clandestini né a quella successiva del loro attraversamento del confine. Dopo averli reclutati, debitamente «istruiti» (31) ed avviati alla partenza del viaggio, gli emissari dei queste organizzazioni riprendono i clandestini nel territorio di destinazione, li consegnano ai parenti ovvero ai loro «padroni», ricevendo in cambio la quantità di denaro pari al prezzo stabilito anticipatamente.
I capi di queste organizzazioni risiedono all'estero. Essi sono in grado di gestire il traffico delle persone in quanto dispongono di ingenti capitali precedentemente accumulati agendo in altri mercati illeciti, primi fra tutti quelli della droga e delle armi.
I capi non vedono e non entrano in contatto con gli immigrati clandestini. Essi si occupano, secondo la logica imprenditoriale, di spostare questa «merce umana» da un continente ad un altro garantendosi, anche in modo violento (32) e attraverso fidati collaboratori, la riscossione del prezzo pattuito per il viaggio, una volta che i migranti sono giunti a destinazione.
I capi svolgono specifiche azioni, quali:
gestiscono i capitali, stabilendo i prezzi (33) e, nella maggior parte dei casi, finanziando i costi del processo migratorio;
scelgono i fornitori di determinati servizi illeciti (organizzazioni criminali di medio livello) e con essi stipulano le condizioni contrattuali, operative e finanziarie, di subappalto di tali servizi;
stabiliscono accordi di collaborazione con altri sodalizi criminali di alto livello sia per lo scambio di servizi, sia ad esempio, per la compravendita di clandestini;
decidono l'avvio di un'azione conflittuale con altri sodalizi criminali di alto livello, nel caso in cui vengano violati i patti stabiliti, come nel caso, per esempio, del furto di un carico di clandestini (34);
gestiscono le relazioni con persone del mondo politico, burocratico, diplomatico, imprenditoriale e finanziario, soprattutto attraverso il compimento di azioni corruttive;
b) livello medio, che può essere identificato nelle organizzazioni criminali operanti in territori strategici (35), in quanto situati nelle zone confinarie con i paesi di destinazione ovvero con quelli che costituiscono un passaggio obbligato verso altri paesi dell'Unione Europea.
Alle organizzazioni di medio livello, le organizzazioni di cui sopra affidano la cosiddetta fase operativa del viaggio, costituita da una serie di mansioni specifiche che, articolandosi su uno spazio fisico e temporale prolungato e diversificato, per essere svolte necessitano di un'ottima conoscenza del territorio locale e di una consolidata rete di rapporti criminali. Queste mansioni consistono: nella predisposizione di documenti falsi, nella corruzione di persone deputate sia al rilascio dei documenti per l'espatrio o al transito frontaliero sia al controllo dei confini; nella scelta delle rotte, delle modalità e dei mezzi di trasporto; nella triplice pianificazione delle modalità: a) di ingresso e di alloggio degli immigrati nei paesi di transito (solitamente, all'interno di abitazioni scarsamente visibili), b) di introduzione clandestina nei paesi di destinazione, c) di consegna dei clandestini agli emissari delle organizzazioni etniche.
Il potere accumulato da queste organizzazioni di medio livello, come è emerso da approfondite indagini giudiziarie, ha consentito loro di arrivare persino al controllo dei centri di permanenza ungheresi, russi e rumeni in cui vengono accolti gli immigrati espulsi dal paese di destinazione. A questo si aggiunga la dimostrata capacità di questi sodalizi criminali di pilotare i respingimenti in paesi in cui è possibile organizzare un nuovo viaggio verso il medesimo paese dal quale gli immigrati sono stati espulsi (36).
Utilizzando i termini del linguaggio commerciale, si può notare come, a differenza delle organizzazioni etniche, le organizzazioni di medio livello operano con una clientela costituita da immigrati provenienti
da diverse nazioni, una parte dei quali oggetto di tratta, occupandosi di organizzare e di fornire a questi ultimi i servizi sopra descritti, consentendo loro di transitare da un paese ad un altro, all'interno del continente europeo, sino al raggiungimento della meta finale.
I capi di queste organizzazioni di medio livello sono in contatto sia con i capi delle organizzazioni del livello superiore, con i quali stabiliscono gli accordi operativi e quelli finanziari, sia con quelli del livello inferiore, cui affidano l'espletamento concreto delle azioni pianificate.
In questo secondo livello rientrano ad esempio le organizzazioni dei passeurs sloveni e quelle degli scafisti albanesi. Entrambe, infatti, sono specializzate nel gestire la ricezione e il trasporto di massa, via terra e via mare, di immigrati clandestini provenienti prevalentemente dall'Asia, dall'Estremo e Medio Oriente e dall'Europa dell'Est, oltre che da altre nazioni.
Le organizzazioni criminali slovene ed albanesi, in relazione all'esperienza criminale accumulata nel tempo e in considerazione dei territori in cui operano, costituiscono attualmente una sorta di agenzia di servizi (37) cui la mafia turca, cinese e russa, in particolare, si rivolgono per trasportare, oltre alle persone, anche droga, armi e tabacchi lavorati esteri.
c) livello basso, costituito da organizzazioni criminali minori che operano sia nelle nazioni di transito sia nelle zone confinarie con i paesi di destinazione.
Queste organizzazioni operano sia su commessa delle organizzazioni di livello medio, sia nei confronti di singoli migranti dotati di un capitale proprio. Le organizzazioni di basso livello, nettamente più numerose di quelle di alto e medio livello, si occupano materialmente di ricevere e di smistare i clandestini, curano il passaggio del confine e l'introduzione clandestina nel territorio di transito ovvero di destinazione, effettuano i trasporti e, infine, provvedono alla consegna degli immigrati agli emissari di altre organizzazioni criminali minori fino ad arrivare, al termine del viaggio, a quelli delle organizzazioni etniche, dai quali ricevono in cambio il denaro che successivamente viene consegnato ai capi.
Il passaggio della frontiera viene effettuato con l'utilizzo di mezzi diversi a seconda delle caratteristiche territoriali della rotta che si deve percorrere, della distanza che separa tra di loro le varie tappe del viaggio complessivo e, infine, in base agli accordi stabiliti, nel caso di smuggling, tra gli immigrati e i trafficanti, nonché di quelli stabiliti tra le varie organizzazioni criminali.
Le inchieste giudiziarie svolte, in particolare - ma non solo - nelle Direzioni distrettuali antimafia di Trieste e di Lecce, hanno anche messo in evidenza come nell'ultima fase del viaggio, consistente
nell'introduzione dei clandestini in Italia e nella loro consegna agli emissari delle organizzazioni etniche, sovente vi sia la partecipazione di manovalanza criminale autoctona che fornisce gli alloggi, svolge il ruolo di autista o di staffetta (confine italo-sloveno) ovvero di tassista verso le stazioni ferroviarie più vicine (Lecce).
Un fenomeno particolarmente grave, denunciato dall'Autorità giudiziaria, è stata la compravendita di visti di ingresso, che ha visto il coinvolgimento - in specifici e limitati casi - di esponenti delle forze dell'ordine, specialmente di personale degli Uffici stranieri di alcune questure (38).
Infine, gli inquirenti hanno avuto modo di accertare come nella produzione dei gommoni utilizzati per il trasporto dei clandestini sulle coste salentine, siano state coinvolte anche aziende pugliesi (39).
2. I rapporti tra le altre mafie e le mafie italiane
I rapporti tra le altre mafie e le mafie autoctone, in relazione ai fenomeni dell'immigrazione clandestina e di tratta, consistono, in particolare, in relazioni d'affari (40), che si traducono concretamente nello scambio di determinati servizi ovvero di determinati prodotti. Un esempio in tal senso è quello che vede, da una parte, le mafie italiane consentire lo sbarco dei clandestini sulle coste meridionali pugliesi, calabresi e della Sicilia, controllando debitamente il territorio onde prevenire eventuali azioni di contrasto delle forze dell'ordine e fornendo assistenza logistica, in cambio, dall'altra, della fornitura di partite di droga, di armi, tabacchi o, in alternativa, di un compenso monetario prestabilito per ciascuno sbarco ovvero quale tassa di occupazione del territorio per l'esercizio della prostituzione, come è stato accertato nel caso dei rapporti tra camorra napoletana e criminalità nigeriana nel casertano e nell'hinterland romano (41).
Rapporti tra mafie italiane e altre mafie si sono registrati anche nella reciproca fornitura della necessaria assistenza per favorire l'espatrio di pericolosi latitanti verso il nostro Paese e dall'Italia in direzione di altri paesi stranieri, in particolare quelli dell'area balcanica.
3. Il traffico degli esseri umani: segmentazione, specializzazione, flessibilità.
L'esame della struttura, delle strategie e delle modalità operative illustrate nelle pagine precedenti, consentono di affermare che il traffico degli esseri umani è un mercato criminale che si caratterizza per un elevato livello di segmentazione, di specializzazione e di flessibilità.
L'illustrazione di questi tre fattori endogeni, non può non essere subordinata ad una premessa specifica.
Il ricorso a network criminali, in grado di fornire servizi finalizzati all'introduzione e al soggiorno illegale in un paese sviluppato, non raggruppa l'intero universo delle modalità utilizzate dai flussi migratori irregolari per spostarsi da un territorio ad un altro, ma ne rappresenta soltanto una di queste (42). Infatti, mantenendo ferma la distinzione tra il favoreggiamento organizzato dell'immigrazione clandestina (smuggling) e la tratta delle persone (trafficking), si è notato che le organizzazioni criminali, entrano in gioco quando:
il migrante sceglie volontariamente di emigrare, ma non dispone completamente delle conoscenze, dei mezzi e del capitale, necessari per affrontare l'intero viaggio. In questo caso il migrante costituisce la domanda di mercato a cui le organizzazioni criminali devono fornire una apposita offerta di servizi specifici.
il migrante (soprattutto le donne e i bambini) viene costretto a lasciare il proprio paese, con la violenza, il ricatto e l'inganno, al fine di essere successivamente sfruttato per fini economici nei mercati illeciti della prostituzione, dell'accattonaggio e dell'economia sommersa presenti nel paese di destinazione. In questa situazione, il migrante costituisce l'offerta di un bene specifico richiesto nei paesi sviluppati.
Nel primo caso (smuggling), le organizzazioni criminali dei trafficanti devono rispondere ad una specifica domanda di servizi nei confronti dei migranti, mentre nel secondo caso (trafficking), esse devono rispondere alla domanda di un determinato bene, i nuovi schiavi (43), nei confronti dei clienti dei mercati illeciti sopra citati, residenti nei paesi di destinazione.
In entrambe le situazioni, tuttavia, i trafficanti devono spostare un numero variabile di persone da un continente ad un altro ovvero da una nazione ad un'altra nello stesso continente ovvero da una regione ad un altra nell'ambito dello stesso stato. Questa, come accennato in precedenza, è la ragione principale - ma non l'unica - che spiega la segmentazione in più livelli delle organizzazioni criminali dedite al traffico degli esseri umani.
La specializzazione delle organizzazioni criminali riguarda sia le risorse umane (44) che quelle strumentali. Essa varia in funzione del livello occupato dalle organizzazioni di trafficanti, dal ruolo che queste ultime sono incaricate di svolgere e dal territorio in cui sono ubicate, ed è frutto sia di un background criminale acquisito precedentemente agendo in altri mercati illegali sia di un sapere criminal-imprenditoriale acquisito con l'esperienza specifica in questo tipo di traffico.
La flessibilità, infine, è direttamente proporzionale, così come la specializzazione, alla duplice necessità di far fronte, da un lato, agli ostacoli di diversa natura che possono presentarsi all'introduzione di persone in modo clandestino o irregolare nel paese di destinazione e, dall'altro, a quella di ridurre i costi e le possibili sanzioni penali in cui si può incorrere per lo svolgimento del traffico delle persone.
In pratica, le domande di beni e servizi cui le organizzazioni di trafficanti devono rispondere, fanno sì che esse debbano segmentarsi, specializzarsi ed essere flessibili rispetto ad una serie di fattori esogeni, tra i quali si possono elencare: la variabilità dell'entità e della provenienza dei flussi migratori (45), le caratteristiche delle politiche migratorie, la normativa di contrasto all'immigrazione clandestina e al traffico di persone presenti nei paesi di origine, di transito e di destinazione unitamente, infine, all'efficacia dell'azione di contrasto degli inquirenti nei paesi menzionati (46).
4. Forme e vie di introduzione degli immigrati nel territorio italiano
A partire dagli anni ottanta, l'Italia si è trasformata da paese di emigrazione (47) a paese di frontiera. La nostra penisola, infatti, per la sua posizione geografica è divenuta un paese di destinazione ovvero un territorio di passaggio obbligato per raggiungere altri paesi, europei o extraeuropei.
In particolare, dagli inizi degli anni novanta del XX secolo, lungo le coste meridionali della Puglia, della Calabria e della Sicilia, e attraverso il confine italo-sloveno, l'Italia ha visto aumentare progressivamente gli ingressi illegali di immigrati sul proprio territorio nazionale. Le ripetute immagini televisive di immigrati clandestini che in Puglia sbarcano dai gommoni provenienti dall'Albania, in Calabria dalle cosiddette «navi carretta» provenienti dalla Turchia, senza dimenticare le intercettazioni di auto e furgoni carichi di disperati alla ricerca di una vita migliore o di donne destinate all'esercizio coatto della prostituzione, che avvengono soprattutto nel nord-est d'Italia, hanno alimentato un allarme cui è necessario rispondere in termini, innanzitutto, di analisi e conoscenza del fenomeno e, successivamente, di azioni preventive e repressive concrete.
Naturalmente, nell'esaminare le forme e le vie attraverso le quali i trafficanti introducono gli immigrati in Italia, va tenuto in considerazione che ciascun flusso migratorio si distingue dagli altri, non solo dal punto di vista quantitativo ma, altresì, per le modalità con le quali raggiunge la nostra penisola, per i costi che gli immigrati sostengono, per le rotte che vengono utilizzate, per il fatto di considerare l'Italia una meta finale ovvero una tappa obbligata di un viaggio destinato a terminare in altre nazioni.
In Italia, così come avviene in altri paesi di destinazione o di transito, i trafficanti di esseri umani introducono gli immigrati in:
forma legale o apparentemente legale. I migranti, in questo caso, sono muniti di visti temporanei regolari o di passaporti e documenti d'ingresso adeguatamente falsificati (48). I motivi per i quali si attesta l'entrata in Italia sono generalmente legati al turismo o allo svolgimento di un particolare tipo di lavoro, molto spesso nell'ambito dello spettacolo. L'entrata nel nostro paese avviene, generalmente, per via marittima, utilizzando traghetti di linea, o per via aerea, utilizzando anche piccoli scali aeroportuali.
L'entrata legale è molto spesso utilizzata per introdurre in Italia giovani donne provenienti dall'Europa dell'Est, da quella Centrale e dall'America Latina, che vengono successivamente impiegate sia nel mercato della prostituzione da strada, sia nel mercato della prostituzione mascherata (49), che si svolge sotto la copertura di attività formalmente legali, all'interno di locali quali ad esempio night-club, club-privati o sale massaggio.
Le forme legali o apparentemente legali vengono utilizzate dai trafficanti anche per introdurre immigrati che dispongono di un capitale proprio di una certa entità, che consente a questi ultimi di acquistare una serie di «servizi» di migliore qualità rispetto ad altri migranti.
L'utilizzo di passaporti falsi è stato riscontrato soprattutto nel caso degli immigrati provenienti dai paesi asiatici. Approfittando della difficoltà che gli agenti delle forze dell'ordine incontrano, in particolare nel territorio interno, nel distinguere somaticamente le persone, soprattutto se giovani, uno stesso passaporto, munito periodicamente di una foto diversa, può essere utilizzato per consentire l'entrata nel territorio nazionale di più immigrati;
forma illegale. I migranti, in questo caso, non sono muniti di documenti di identità ovvero dispongono di documenti palesemente falsi. Sprovvisti di un capitale proprio sufficiente per emigrare ovvero sottoposti alla tratta, gli immigrati in questo caso, raggiungono l'Italia in tempi molto più lunghi e affrontano viaggi molto più pericolosi rispetto agli immigrati che entrano con le modalità descritte in precedenza. Nel corso del viaggio, composto di un certo numero di tappe intermedie, i clandestini sono oggetto di diverse forme di violenze, tra le quali le più frequenti sono: gli stupri, individuali e collettivi, attuati soprattutto nei confronti delle giovani donne da avviare successivamente sul mercato della prostituzione; i sequestri di persona; la sottoposizione a percosse corporali; il malnutrimento.
I trafficanti introducono illegalmente in Italia gli immigrati utilizzando sia la via terrestre, in particolare lungo il confine italo-sloveno, sia la via marittima, in particolare le coste pugliesi, calabresi, siciliane. Nel corso del 1999, sono stati accertati sbarchi anche sulle coste del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, della riviera romagnola, delle Marche e dell'Abruzzo.
I trafficanti di persone utilizzano una serie di vie e di mezzi per introdurre nel territorio nazionale, e in altri paesi di destinazione, migliaia di immigrati alla ricerca di un futuro migliore.
L'utilizzo di determinate vie e, conseguentemente, di specifici mezzi è stabilita in relazione ad una serie di fattori, tra i quali:
la disponibilità e, in caso positivo, l'entità del capitale di cui dispongono gli immigrati
la distanza e le caratteristiche geografiche del territorio che separa il paese di destinazione da quello di origine
i rapporti esistenti tra le organizzazioni criminali
il livello dei controlli alle frontiere
il grado di efficacia dell'attività di contrasto della magistratura e delle forze dell'ordine nei paesi di origine, transito e destinazione.
Nella penisola italiana, gli immigrati vengono introdotti:
via mare: soprattutto nelle coste meridionali attraverso l'utilizzo di gommoni, pescherecci, e navi definite «carrette del mare». I traghetti di linea sono utilizzati sia per il trasporto legale di immigrati, sia per trasporti illegali, che frequentemente consistono nell'occultare
i clandestini all'interno di container, di TIR dotati di apposite intercapedini o di camion frigorifero (50).
via terra: lungo il confine tra l'Italia, la Slovenia, la Francia, l'Austria. Gli immigrati vengono introdotti a piedi, su auto, pullman, furgoni o TIR muniti di doppiofondo o di apposite intercapedini;
via aerea: utilizzando grandi e piccoli scali aeroportuali.
5. I punti di introduzione degli immigrati in Italia.
Diversi sono i punti del territorio italiano attraverso i quali i trafficanti di esseri umani introducono illegalmente gli immigrati.
Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, relativamente alle forme e alle modalità di ingresso, nelle pagine che seguono si descriveranno in modo specifico le dinamiche organizzative, gestionali e finanziarie, nonché le rotte, che coinvolgono l'Italia nel traffico degli esseri umani.
5.1 Il confine italo-sloveno.
Una porta d'ingresso utilizzata dai trafficanti per introdurre immigrati clandestini in territorio italiano è il confine italo-sloveno. Ogni notte il carso sloveno-giuliano, la città di Trieste e le zone limitrofe (Gorizia e Udine) sono attraversate da un numero non trascurabile di immigrati clandestini.
La Procura della Repubblica di Trieste, sulla base di indagini particolarmente accurate, ha stimato che ogni anno dalla Slovenia entrano in Italia non meno di 35.000 clandestini (51). Questa cifra, stimata per difetto, si fonda sul presupposto che per ogni clandestino rintracciato almeno quattro o cinque riescono ad eludere i controlli e a raggiungere la loro meta prefissata. Si tratta di immigrati provenienti dall'Europa centrale e orientale (jugoslavi, rumeni, bosniaci, macedoni, moldavi, bulgari), dal medio oriente (turchi e irakeni di etnia curda), dal subcontinente indiano (bengalesi, pakistani, srilankesi), dall'Asia (cinesi e filippini). In particolare, tra le persone provenienti dal centro e dall'est europeo, la maggior parte è costituita da giovani donne, molte delle quali minorenni, di origine ucraina, moldava e russa, destinate successivamente al mercato della prostituzione da strada italiano.
Il fenomeno dell'immigrazione clandestina, così come quello di altri fenomeni illegali (es. contrabbando, traffico di armi e di droga) lungo il confine che separa l'Italia dalla Slovenia non costituisce una novità. Alla fine degli anni '70, in forma molto limitata, transitavano attraverso il confine italo-sloveno cittadini ex jugoslavi diretti verso l'Austria, la Germania occidentale, la Svizzera e il Friuli Venezia Giulia. Durante gli anni ottanta, si sono registrate le prime entrate di immigrati provenienti dai paesi medio orientali e asiatici. Il passaggio del confine era favorito da persone, i passeurs che, disponendo di una particolare conoscenza dei sentieri dei boschi che separano la Slovenia dalla penisola italiana, in forma autonoma e saltuaria, introducevano illegalmente nel territorio nazionale gli immigrati clandestini.
Tra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta, i flussi migratori si sono modificati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, implicando una conseguente modifica della gestione illegale dell'immigrazione clandestina anche lungo il confine italo-sloveno. I singoli trasportatori di un tempo hanno iniziato a costituire organizzazioni dotate di una gerarchia minima, hanno reclutato gli immigrati clandestini, si sono dedicati alla pianificazione dei viaggi e hanno iniziato ad affidare l'esecuzione degli stessi, compreso l'attraversamento del confine verso l'Italia, ad alcuni collaboratori pagati al termine di ciascuna operazione.
La Procura della Repubblica di Trieste, grazie all'attività investigativa svolta da un apposito pool di magistrati ed investigatori attivo dal 1997, ha ricostruito le rotte attraverso le quali, immigrati di diversa nazionalità entrano in Italia attraverso il confine italo-sloveno. I casi trattati, hanno dimostrato come le organizzazioni dei passeurs sloveni, classificabili tra quelle di medio livello, abbiano sviluppato competenze tali da renderle capaci di gestire la parte del viaggio che gli immigrati devono compiere dall'ex Unione Sovietica, in particolare dalla città di Kiev in Ucraina, passando attraverso la Romania, l'Ungheria, la Croazia, la Slovenia e l'Italia (52).
Dal Bangladesh, muniti di visti per affari o di altri documenti rilasciati dalle rappresentanze consolari e ottenuti attraverso il pagamento di cospicue somme di denaro, i clandestini raggiungono Mosca in aereo. Gli stessi, quindi, proseguono il loro viaggio a bordo di autovetture, camion o piccoli furgoni, verso Kiev, in Ucraina, dove sostano qualche giorno, per poi continuare verso Budapest. Da questa città, snodo fondamentale per il traffico delle persone, gli immigrati vengono diretti in Slovenia e, da qui, in Italia.
La pianificazione del viaggio è curata da un'organizzazione criminale bengalese che si avvale di manovalanza criminale di diversa nazionalità nel corso delle varie tappe.
Immigrati clandestini che attraversano zone impervie e boschive vicino Trieste, Gorizia e Udine, provengono anche dall'area balcanica, in particolare dalla Macedonia, dal Montenegro, dal Kosovo, dalla Jugoslavia.
Due sono le modalità seguite dagli immigrati clandestini per entrare in Italia. Un prima modalità consiste nel rivolgersi a pseudo agenzie turistiche che provvedono all'organizzazione del viaggio fino a Lubiana o a Zagabria; da queste città, si parte successivamente per entrare in Italia ovvero si prosegue anche fino agli Stati Uniti. Una seconda modalità, vede gli aspiranti migranti dirigersi fino a Lubiana autonomamente. In questa città, gli immigrati sono soliti rivolgersi ad apposite persone che tutti sanno essere specializzate nel trasporto clandestino verso l'Italia, generalmente svolto con autovetture o furgoni. Il confine italo-sloveno viene varcato con l'aiuto di passeurs che, una volta giunti a destinazione, consegnano i clandestini nelle mani di altre persone, che hanno l'incarico di trasportarli verso la meta prestabilita.
L'immigrazione illegale più consistente registrata nella provincia di Trieste è costituita da immigrati clandestini originari della Romania. Quella che è stata definita l'altra immigrazione (53), perché silenziosa e quindi ignorata dai media, è gestita da organizzazioni locali rumene, caratterizzate da una struttura organizzativa molto semplificata e rudimentale. La rotta seguita da questo flusso migratorio parte dalla Romania, attraversa la Croazia, la Slovenia e termina in Italia dove, successivamente, molti clandestini rumeni proseguono verso le città di Roma, Milano e Torino, dove esiste un'elevata domanda di lavoro nero, specialmente nel settore dell'edilizia.
Coloro che dalla Romania intendono raggiungere l'Italia si rivolgono alle organizzazioni sopra citate che, senza alcun problema o timore, pubblicano offerte di accompagnamenti illegali mediante apposite inserzioni sui quotidiani o scrivono sui muri delle città frasi del tipo: «Porto gente in Italia», «Offresi per accompagnamento in Italia», «Massima serietà ed esperienza per accompagnamenti in Italia».
Il confine carsico-giuliano è attraversato anche da immigrati clandestini provenienti dalle Filippine, dal Pakistan, dall'Egitto. I viaggi illegali verso l'Italia e altri stati dell'Unione Europea sono programmati e pianificati, come si è visto in precedenza, da grossi trafficanti che risiedono negli stessi paesi di origine dei flussi migratori. Un nodo fondamentale, dal quale transitano gli immigrati provenienti da queste nazioni, è costituito dall'Ungheria, paese nel quale i trafficanti possono contare sull'appoggio di apposite organizzazioni che si occupano di garantire un alloggio sicuro e segreto agli immigrati, si occupano del loro smistamento e del loro successivo spostamento verso i paesi di destinazione. L'ultimo tratto del viaggio viene solitamente svolto mediante l'utilizzo di autovetture, camion, furgoni fino all'area confinaria con l'Italia dove ad attendere i clandestini vi sono i passeurs che provvedono a curare l'attraversamento dei boschi e la consegna degli immigrati ai committenti.
La via terrestre è utilizzata dai trafficanti anche per introdurre illegalmente in Italia persone provenienti dalla Comunità degli Stati Indipendenti, dall'Ucraina, dalla Moldavia, dalla Lettonia, dalla Estonia e dalla Bielorussia. I flussi migratori provenienti da questi paesi sono
composti prevalentemente, come detto in precedenza, da giovani donne destinate successivamente ad essere sfruttate nel mercato della prostituzione italiano. Queste ragazze, spesso minorenni, sono reclutate mediante l'inganno, la violenza ed il ricatto. Nel primo caso, generalmente, i trafficanti promettono un lavoro legale e ben retribuito nel paese di destinazione; nel secondo caso, si assiste all'esecuzione di veri e propri sequestri di persona; nel terzo caso si minacciano azioni violente sia nei confronti delle giovani donne sia nei confronti dei loro familiari, in particolare dei loro figli.
Una volta reclutate, le donne sono trasportate a Budapest, dove alloggiano segregate all'interno di abitazioni appartenenti a soggetti dell'organizzazione che attua il traffico. Il viaggio, a bordo di autovetture o furgoni, prosegue successivamente fino al confine ungherese-sloveno, dove appositi passeurs aiutano le giovani ragazze ad attraversare il confine per continuare la loro odissea fino a Lubiana. L'ultimo tratto prevede il trasferimento dalla Slovenia all'Italia, con le stesse modalità utilizzate per la parte precedente del viaggio. Giunte in Italia, le ragazze sono caricate su autovetture o furgoni del «committente», ossia del soggetto che ne sfrutterà in seguito le loro prestazioni sul mercato della prostituzione da strada. Percorsi alcuni chilometri, queste donne vengono fatte scendere per essere sottoposte alla compravendita che si svolge in alcune aree di servizio dell'autostrada A 4, in direzione Venezia.
Particolarmente in aumento si è dimostrato il flusso di immigrati clandestini provenienti dalla Cina. I clandestini provengono soprattutto da alcune regioni cinesi ed in particolare dallo Zheijang, dal Wen Zhon, dal Cin Tien e dal Fujan. Il viaggio dalla Cina ad un paese dell'Europa occidentale costa dai 25 ai 30 milioni e può durare anche fino a due anni; se l'immigrato cinese deve essere trasferito da un altro paese europeo, la somma si dimezza (54).
I clandestini cinesi vengono reclutati nei loro luoghi di origine o, come accade molto più frequentemente, gli stessi si rivolgono a loro amici e conoscenti che hanno già fatto un viaggio clandestino in Europa o hanno aiutato qualcun altro a compierlo. A questo punto viene contattata una persona, chiamata «il padrone», generalmente membro della mafia cinese, verso la quale gli immigrati manifestano un elevato timore reverenziale.
I clandestini cinesi consegnano al «padrone» una cospicua somma di denaro e due fotografie, che serviranno per poter usufruire di un passaporto e di un visto per la Jugoslavia. Nell'attesa che la documentazione venga preparata, gli aspiranti migranti attendono la partenza del viaggio a casa loro. Giunto il momento adatto, i clandestini vengono fatti partire per un primo tratto di viaggio, che si svolge in treno, con destinazione Pechino. Dopo aver pernottato qualche giorno, gli immigrati vengono imbarcati su un volo aereo per Belgrado dove, una volta scesi dall'aereo, sono accolti da un esponente dell'organizzazione
che provvede a portarli all'interno di apposite abitazioni. Frequentemente, durante questi trasferimenti, i clandestini sono incappucciati e nel corso della loro permanenza sul suolo serbo, vivono una condizione di vero e proprio sequestro di persona: non possono uscire di casa, sono controllati costantemente, il loro nutrimento consiste in pane e acqua.
L'ingresso nel nord-est del territorio italiano avviene prevalentemente via terra, ma non sono mancate esperienze di introduzione illegale via mare. Nel primo caso, i clandestini vengono introdotti prima in territorio sloveno e quindi in quello italiano, mediante l'attraversamento dei rispettivi confini coadiuvati dagli appositi passeurs del luogo.
Nel secondo caso, l'entrata via mare, esistono due direttrici. La prima vede gli immigrati cinesi partire da Belgrado, proseguire verso il Montenegro, l'Albania e, da qui, arrivare sulle coste pugliesi. La seconda, passa attraverso la Romania, la Croazia e termina sulle coste del Friuli Venezia Giulia o del Veneto. Le recenti inchieste condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Trieste hanno accertato che dal settembre 1999 al giugno 2000, sono stati compiuti 35 sbarchi di immigrati cinesi e bengalesi, divisi tra le coste friulane, venete, romagnole e pugliesi. Uno degli sbarchi è avvenuto di fronte al Casinò del Lido di Venezia, gli altri a Lignano, a S. Croce, a Grado, a Trieste, a Ravenna e a Vieste. Gli inquirenti hanno accertato l'esistenza di cinque linee di introduzione degli immigrati via mare, gestite da organizzazioni criminali italo-slovene che, nel periodo sopra considerato, hanno introdotto in Italia circa 12.000 persone, realizzando un fatturato criminale stimato in 250 miliardi di lire.
Al fine di comprendere le modalità attraverso le quali viene gestito questo traffico degli esseri umani via mare dalla Slovenia all'Italia, è utile riportare un brano tratto dalla richiesta di custodia cautelare emessa della Procura triestina: «LONCARIC organizzava i traffici (talora di persona valendosi della collaborazione di BJELICA) ingaggiando i clandestini e tenendo i contatti sia con le persone adibite al loro trasporto sia con i committenti; KRIVICIC custodiva i clandestini a Lussino; RAMBELLI Raoul fungeva da scafista; RAMBELLI Herbert sceglieva il luogo dello sbarco e segnalava da terra il via-libera allo sbarco; GREGORI e TERDINA fungevano da raccordo tra gli organizzatori slavi, i fratelli RAMBELLI e gli autisti cinesi, e segnatamente: si incontravano con gli autisti cinesi, li guidavano fino al luogo dello sbarco e qui assistevano e aiutavano nella fase di consegna dei clandestini dai RAMBELLI ai cinesi, facendo altresì segnalazioni luminose da terra allo scafo; i singoli autisti cinesi, incaricati del ritiro dei clandestini, erano inviati da N.N. e da altri organizzatori cinesi non noti; N.N. si prestava consapevolmente e con continuità a noleggiare i furgoni ai cinesi e faceva altresì in almeno una occasione da staffetta. I pagamenti venivano fatti ad emissari dell'organizzazione slovena.
Quanto ai clandestini del Bangladesh, invece, non venivano ritirati dagli organizzatori etnici ZZAMAN, MONDIAL e HOSSAIN, e raggiungevano con mezzi propri le destinazioni finali; ciò in quanto per il pagamento dell'organizzazione il denaro era stato lasciato in anticipo presso un garante, sicché l'organizzazione non aveva bisogno di trattenere
i clandestini quale «pegno», cosa che invece facevano i gruppi criminali cinesi, che per questa ragione ritiravano i clandestini al momento dello sbarco» (55).
Una volta giunti in Italia, i clandestini cinesi non vengono lasciati liberi ma, al contrario, rimangono ancora nella condizione di sequestrati, in attesa che i parenti o i committenti si rechino dagli emissari dell'organizzazione a pagare il riscatto. Ogni clandestino conosce la sua destinazione. Se l'organizzazione dedita la traffico dei migranti non conosce i parenti o i committenti dei migranti, come si è constatato in alcune indagini, dispone comunque di numeri di telefono dai quali è possibile risalire a questi ultimi, sia che risiedano in Europa o in Cina. Utilizzando telefoni cellulari, gli emissari dei trafficanti provvedono a contattare i parenti o i committenti ed iniziano la trattativa per stabilire l'entità del riscatto che dovrà essere pagato per liberare i clandestini. Durante questa fase, come attestato da un rilevante numero di intercettazioni telefoniche e da testimonianze dirette, per convincere la controparte a versare rapidamente il riscatto, i trafficanti fanno sentire al telefono le urla degli immigrati che vengono percossi, picchiati brutalmente e costretti a combattere a testate tra di loro.
Il riscatto che viene pagato costituisce il debito che ciascun clandestino dovrà successivamente risarcire al suo parente o committente. La restituzione del debito avviene secondo modalità che vedono l'immigrato clandestino cinese ridotto in una condizione di schiavitù, costretto a lavorare per 18 ore al giorno, negli stessi luoghi in cui vive, in condizioni igienico-sanitarie precarie.
I principali mercati nei quali i clandestini cinesi sono inseriti sono quello della ristorazione e quello dei laboratori di pelletteria, anche se non mancano casi di esercizio coatto della prostituzione non lungo le strade ma all'interno di sale massaggio.
Pertanto, a differenza di altri casi (es. i bengalesi), i clandestini cinesi non vengono dispersi sul territorio, ma vengono assorbiti nelle comunità di loro connazionali, all'interno delle quali si registra la mimetizzazione dei gruppi criminali che gestiscono i canali clandestini di ingresso nel territorio dello Stato e lo sfruttamento degli immigrati.
Il numero degli stranieri rintracciati sul confine italo-sloveno se nel 1999 era di 5.514 unità, al 12 novembre del 2000, risulta pari a 9.285 unità. Nello stesso arco temporale, il numero di mezzi sequestrati è di 211 unità per il 1999, mentre a novembre dell'anno in corso è pari a 191 unità. (Tab. n. 2).
Analizzando la composizione dei flussi migratori in base alla numerosità e alla nazionalità, si può notare che, mentre nel primo anno considerato (1999) i primi tre posti della classifica dei rintracci erano occupati da immigrati provenienti dalla Jugoslavia, dalla Romania e dall'Iraq, nell'anno in corso, al primo e al secondo posto troviamo immigrati provenienti dall'Iran e dalla Turchia mentre, pur facendo registrare circa lo stesso valore dell'anno precedente, la Romania occupa la terza posizione. Questi dati, denotano, dunque,
come il confine italo-sloveno sia passato da via d'entrata per flussi migratori provenienti prevalentemente dai Balcani e dall'Europa dell'Est, a varco per i flussi migratori composti da immigrati curdi, provenienti prevalentemente dall'Iran, dall'Iraq e dalla Turchia.
In aumento risulta anche il numero degli immigrati provenienti dal Sub-Continente indiano, in particolare dal Bangladesh e dall'Afganistan, mentre per quanto riguarda i flussi provenienti dalla regione balcanica, l'unico paese che evidenzia un incremento dei flussi migratori verso l'Italia è l'Albania.
Significativo, infine, è il rintraccio di 341 cittadini moldavi, molti dei quali sono donne costrette successivamente all'esercizio coatto della prostituzione.
Tab. 2

5.2 Le coste pugliesi.
Sono circa novantamila i cittadini extracomunitari sbarcati clandestinamente e rintracciati sulle coste leccesi nel corso degli anni novanta (56).
La Puglia, e il Salento in particolare, geograficamente vicine alla dirimpettaia regione balcanica, costituiscono un crocevia estremamente importante per il traffico degli esseri umani e per una serie di altri traffici illeciti, tra i quali, quello degli stupefacenti, quello delle armi e quello dei tabacchi lavorati esteri.
I primi consistenti flussi migratori che hanno raggiunto l'Italia, attraversando il Canale d'Otranto a bordo di scafi, gommoni, «carrette del mare» e, in alcuni casi, con traghetti di linea, sono stati quelli dei cittadini albanesi, fuggiti in massa dal loro paese dopo la caduta del regime comunista che sino a quel momento aveva governato il paese delle Aquile (57).
I germi della nascita di un vero e proprio mercato illecito di traghettamento dei migranti dall'Albania all'Italia, dotato di strutture, mezzi e capitali, sono emersi dopo il rimpatrio degli albanesi nel 1991.
I primi viaggi sono stati compiuti sia da malavitosi italiani che, già attivi nel contrabbando di tabacchi e lavorati esteri e in contatto con alcuni malavitosi albanesi, hanno convertito ovvero diversificato le loro attività agendo anche nel trasporto degli esseri umani, sia da parte di persone che, pur non facendo parte di alcuna organizzazione criminale, ma disponendo di un motoscafo, hanno arrotondato i loro bilanci personali fornendo un passaggio ai migranti, in cambio di un compenso oscillante tra le 500 mila lire e 1 milione.
Gli «utenti» di questo servizio, in particolare verso la metà degli anni novanta, non sono stati più soltanto cittadini albanesi ma, come il Comitato ha avuto modo di constatare nel corso delle audizioni svolte e dagli atti giudiziari esaminati (58), anche i migranti provenienti da altri continenti, tra i quali l'Africa, l'Asia, il Sub-Continente Indiano, cui si sono affiancate numerose persone provenienti dall'Europa Orientale e Centrale, oltre agli immigrati curdi.
Questo fenomeno si è particolarmente accentuato a partire dalla primavera di quest'anno, tanto da imporre la modificazione degli indirizzi delle politiche di contrasto concordati dai governi italiano e albanese. Nel protocollo d'intesa, firmato a luglio, si riconosce che il contrasto al fenomeno non può più essere confinato alla sola via marittima (59).
L'aumento progressivo dei flussi migratori, unitamente alla debole risposta degli apparati istituzionali repressivi albanesi, dovuta all'instabilità politica e alla diffusa corruzione presenti in quel Paese, ha consentito alle bande albanesi di accumulare ingenti capitali e di acquisire una consistente autonomia finanziaria che, a sua volta, ha permesso a questi criminali di unire alla gestione della fase di reclutamento dei migranti, quella del loro trasporto, effettuando il traghettamento con mezzi acquistati autonomamente o appositamente affittati da altri connazionali.
L'autonomia finanziaria, unita alla capacità e alla professionalità dimostrate nell'attraversamento del canale d'Otranto, ha permesso ai criminali albanesi di diventare i titolari del monopolio di una vera e propria industria del trasporto via mare e dell'ingresso clandestino di persone, stupefacenti e armi in Italia. L'affidabilità dimostrata da questi sodalizi è stata tale che essi svolgono questa attività di traghettamento verso la penisola italiana non solo in nome e per conto proprio, ma anche in nome e per conto di altre organizzazioni criminali.
A testimonianza e a completamento di quanto appena affermato occorre ricordare, inoltre, che l'Albania è diventata un punto di riferimento fondamentale per le organizzazioni mafiose dell'est europeo, della Cina e della Turchia (60), non solo per la propria posizione geografica, ma anche in seguito alle modifiche che la vecchia rotta balcanica della droga ha subito con i conflitti bellici scoppiati in quella regione.
Gli ingenti capitali accumulati e la dimostrata efferatezza nell'utilizzo della violenza, hanno fortemente contribuito ad aumentare la potenza della criminalità albanese, che ha dimostrato di aver ottenuto la legittimazione per stipulare accordi con organizzazioni malavitose più consolidate e di maggiore spessore delinquenziale che, oltre a quelle sopra menzionate, comprendono anche quelle contrabbandiere baresi, brindisine e napoletane. Infatti, come affermano fonti giudiziarie, proprio tra gli albanesi e i contrabbandieri sono stati stabiliti degli accordi di spartizione territoriale, finalizzati ad evitare indebite ed indesiderate interferenze da parte delle forze dell'ordine in seguito allo svolgimento delle reciproche attività illecite (61).
In base a questi accordi, i contrabbandieri utilizzano per i loro sbarchi di sigarette la fascia costiera adriatica da Brindisi a Bari, in quanto più vicina al Montenegro, stato in cui si è avuta prova dell'esistenza di appositi magazzini di stoccaggio e di latitanti italiani che dirigono questo traffico illecito, mentre gli albanesi implicati nel traffico delle persone utilizzano la fascia costiera a sud di Brindisi e sino a Santa Maria di Leuca (62), in quanto più vicine al golfo di
Valona, zona dalla quale partono la gran parte dei gommoni carichi di clandestini verso l'Italia (63).
I gommoni utilizzati per trasportare i clandestini in partenza dal porto di Valona, di Durazzo sono i cosiddetti oceanici. Questi mezzi, aventi una lunghezza oscillante tra gli 8 e i 12 metri e dotati di una chiglia in vetroresina, sono muniti di due motori potentissimi da 200 HP e di serbatoi supplementari e sono in grado di trasportare 30/40 persone ciascuno, avendo un'autonomia di viaggio di almeno cinque ore. Questi natanti, del costo di circa 100 milioni l'uno, sono spesso intestati a dei prestanome che li hanno acquistati regolarmente e che, per il servizio reso alla criminalità, ricevono un compenso di 500/600 mila lire per ciascuna imbarcazione loro intestata. I gommoni, alcuni dei quali dotati anche di roll-ball e di radar, partono spesso in ore notturne, pilotati da un equipaggio composto di due o tre persone; il viaggio verso le coste pugliesi dura circa due ore e costa circa un milione di lire.
Giunti in prossimità delle coste italiane, gli immigrati vengono fatti rapidamente sbarcare ad alcuni metri dalla riva, senza alcun riguardo per la loro età o per il loro stato di salute, tant'è vero che in presenza delle forze dell'ordine gli scafisti non esitano a farsi scudo con bambini di tenera età, come accaduto nelle acque del Canale di Otranto il 21 ottobre 2000 (64).
Si deve inoltre ricordare, che nell'atto del compimento del proprio dovere di pattugliamento delle acque del Canale d'Otranto, prestando primaria attenzione all'incolumità delle persone trasportate, il 23 luglio, due giorni dopo la visita in Puglia di una delegazione della Commissione parlamentare antimafia, a seguito dello speronamento da parte di un gommone che stava completando lo sbarco di immigrati sulle coste pugliesi, hanno perso la vita i finanzieri Daniele Zoccola e Salvatore De Rosa.
Questo tragico episodio in cui hanno perso la vita i due finanzieri, ha messo in evidenza come il contrasto all'immigrazione clandestina in mare sia particolarmente difficile per la tensione rivolta da un lato, al salvataggio di vite in pericolo e, dall'altro, al contrasto di pericolosi criminali.
Una volta a terra, i clandestini vengono ricevuti e smistati dai referenti delle organizzazioni albanesi presenti in territorio pugliese, individuabili sia in cittadini del paese delle Aquile già regolarmente residenti in Italia sia in salentini a loro collegati, che possono essere vicini ad ambienti criminali associati ovvero riuniti in aggregazioni, a volte occasionali o familiari, di modesto livello criminale.
Immediatamente o dopo alcuni giorni, gli immigrati vengono condotti nelle stazioni ferroviarie di piccoli paesi o, nella peggiore delle ipotesi, vengono consegnati ai rappresentanti delle organizzazioni etniche, in particolare nel caso dei cinesi, o vengono prelevati dai loro committenti, come nel caso delle giovani ragazze costrette all'esercizio coatto del meretricio nel centro-nord Italia.
Un aspetto peculiare delle coste salentine è che il traffico degli esseri umani viaggia di pari passo con quello della droga, in particolare della marijuana e dell'hashish, oltre che della cocaina e dell'eroina (65). Molto spesso, infatti, i gommoni che trasportano persone contengono anche carichi di queste droghe, di cui l'Albania può essere considerata attualmente tra i primi produttori mondiali (66). In questo modo, i criminali albanesi attuano delle vere e proprie economie di scala che consentono loro di realizzare ingenti e rapidi guadagni, scaricando l'intero rischio sugli immigrati. In alcuni casi, infatti, questi ultimi pagano una parte o l'intero viaggio facendo i corrieri della droga o sono successivamente utilizzati per attività inerenti il piccolo spaccio.
L'attività di favoreggiamento organizzato dell'immigrazione clandestina unitamente alla tratta dei migranti, soprattutto di donne da avviare alla prostituzione, ha spinto gli inquirenti ad evidenziare come queste attività malavitose abbiano consentito alle organizzazioni criminali straniere di penetrare nel territorio pugliese, approfittando anche della debolezza dell'organizzazione mafiosa autoctona denominata «Sacra corona unita», dovuta alla pronta ed efficace opera di contrasto svolta dall'autorità giudiziaria. Tuttavia, la presenza di criminali albanesi e dell'est europeo, ha modificato anche la struttura della criminalità autoctona che, da una logica di schieramento, legata alla costituzione di gruppi fortemente coesi, è passata ad una logica commerciale, che giustifica l'accantonamento delle appartenenze storiche e consente la costituzione di alleanze, anche temporanee, giustificate dalla convenienza, in primis economica, per lo svolgimento di specifiche e singole attività criminali (67). Il pericolo concreto, dunque, è quello derivante dalla formazione di nuovi rapporti criminali transnazionali, cui seguono conseguentemente, il nascere di nuove opportunità criminali e il potenziamento di gruppi ed aggregazioni delinquenziali locali.
5.3 Le coste calabresi.
Le coste calabresi, in particolare quelle crotonesi e reggine, sono interessate soprattutto dallo sbarco di immigrati curdi, provenienti dalla Turchia e dall'Iraq, a fianco dei quali vi sono persone provenienti dai paesi arabi, dall'Africa e dal Sub-Continente indiano.
Gli immigrati che giungono sulle coste calabresi affrontano lunghi ed estenuanti viaggi, e compiono il tratto verso l'Italia a bordo di vecchie imbarcazioni, denominate «carrette del mare», provenienti soprattutto dai porti turchi e libanesi che, una volta giunte nelle vicinanze delle coste italiane, vengono abbandonate in balia del mare, in attesa dell'arrivo dei soccorsi.
Su queste imbarcazioni a perdere viaggia anche l'equipaggio, costituito da membri delle organizzazioni dei trafficanti. Spesso, il comandante e i suoi uomini, dopo aver manomesso il timone e i motori delle navi, fuggono a bordo di imbarcazioni giunte appositamente sul luogo concordato; in altri casi, invece, alcuni marinai vengono successivamente arrestati dall'Autorità giudiziaria una volta raggiunta la terra ferma.
In genere, i curdi considerano l'Italia un passaggio obbligato verso la meta finale, costituita dall'Europa Centrale, in particolare la Germania, ovvero dal Nord America.
Gli investigatori hanno accertato che l'attività di trasporto dei curdi è pianificata ed organizzata da tre organizzazioni criminali con sede a Instanbul. In questa città, i tre sodalizi criminali hanno istitutito una centrale operativa, dotata di una propria struttura logistica, mentre in città di altre nazioni, come ad esempio la Grecia, l'Albania, il Pakistan, il Bangladesh e alcuni paesi dell'ex Unione Sovietica, hanno dato vita a delle apposite sottostrutture deputate all'organizzazione dell'immigrazione clandestina (68).
5.4 Le coste siciliane.
La Sicilia è interessata prevalentemente dai flussi migratori provenienti dal Nord Africa, dall'Africa Sub- Sahariana e, in misura minore, da quelli provenienti da alcuni stati arabi e dal Sub-Continente indiano.
Generalmente, sono le coste sud-occidentali e le isole di Lampedusa e di Pantelleria i luoghi dove i clandestini nordafricani vengono sbarcati più frequentemente ad opera soprattutto di pescatori tunisini che utilizzano i loro pescherecci per questo tipo di traffico illecito.
Il versante costiero siracusano e ragusano, invece, è maggiormente interessato dagli immigrati provenienti dai paesi arabi e dal Sub-Continente Indiano, partiti a bordo di scafi veloci, salpati dai porti maltesi.
L'approdo di immigrati curdi, indiani, pakistani, cingalesi e bengalesi sulle coste orientali siciliane, in alcuni casi, viene effettuato dai trafficanti con le stesse modalità utilizzate in Calabria, vale a dire con l'utilizzo delle «navi carretta» ovvero mediante l'impiego di scafi o di imbarcazioni di dimensioni ridotte sulle quali vengono trasbordati i clandestini di diverse nazionalità giunti sino al punto di mare concordato, viaggiando a bordo di navi di grosso tonnellaggio.
A questo proposito si deve ricordare il tragico naufragio avvenuto nel mare di Sicilia, la notte di Natale del 1996, in seguito allo scontro tra la nave Yohan, battente bandiere honduregna, ed un peschereccio maltese, durante la fase di trasbordo degli immigrati, effettuata con il mare in tempesta (69). In quel terribile evento, sono perite, secondo le stime, ben 283 persone di nazionalità pakistana, indiana e cingalese che, per quel viaggio, avevano pagato 7.000 dollari ciascuno.
Una breve descrizione della vicenda è indicativa di come esistano dei veri e propri network criminali in grado di organizzare il trasporto verso una determinato territorio di immigrati di diverse nazionalità e, come, dall'altra, si registrino delle difficoltà nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale.
La Yohan, partita dal porto di Alessandria d'Egitto con a bordo un certo numero di clandestini, viene raggiunta nel Mediterraneo da un'altra nave la Friendship, salpata dalla Turchia, per effettuare un primo trasbordo di persone da quest'ultima imbarcazione alla prima. Successivamente, dopo circa un mese di viaggio nel Mediterraneo, la Yohan approda a Malta, luogo nel quale i trafficanti stabiliscono l'accordo con il peschereccio per il trasbordo degli immigrati verso le coste siciliane.
La notte di Natale, con il mare molto mosso, durante il passaggio dall'una all'altra imbarcazione si verifica una forte collisione e il peschereccio maltese cola a picco con il suo carico di immigrati e con l'intero equipaggio.
A questo punto, il comandante della Yohan si dirige verso le coste greche del Peloponneso, dove vengono scaricati 107 sopravvissuti. Le testimonianze di questi ultimi, la segnalazione della capitaneria di porto maltese del mancato rientro del peschereccio e il ritrovamento di due cadaveri al largo dell'isola di Lampedusa, spingono le autorità, prima fra tutte quella greca, ad avviare un'inchiesta; anche in India, su sollecitazione delle associazioni fondate dai parenti delle vittime, gli inquirenti si attivano per comprendere la sorte degli immigrati.
Dopo la caduta di attenzione, durata diverse settimane, la vicenda di questo naufragio torna alle cronache nel mese di marzo del 1997, quando un giornalista inglese, leggendo quanto era scritto sotto un manto di vernice di una nave ancorata nel porto di Reggio Calabria, scopre trattarsi della Yohan.
Nelle stive interne della nave, gli immigrati avevano scritto frasi del tipo «Pray to God, only God . Help you to God ... from this jail ... By India (Punjab)... Thalander Singh ... 12.96».
Le inchieste giudiziarie svolte, dalle autorità greche, indiane e italiane (Reggio Calabria e Siracusa) hanno accertato l'avvenuto naufragio e la Procura della Repubblica di Siracusa ha emesso una richiesta di rinvio a giudizio per il comandante della nave, l'armatore (70) e l'equipaggio della Yohan, con l'accusa di favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina, di omicidio colposo, di mancato soccorso e di associazione per delinquere.
Tutti gli indagati sono latitanti, compreso il comandante libanese, Yousouf Tallal, che in Italia era già stato arrestato e successivamente scarcerato per decadenza dei termini o per conflitti di competenza territoriale tra le procure. Inoltre, si è avuto modo di constatare che notizie importanti e dettagliate, raccolte in India, sono state per lungo tempo completamente sconosciute alla procura di Siracusa e che il giudice indiano non ha potuto assicurare alla giustizia i trafficanti del suo paese perché il disastro si è verificato al di fuori della sua giurisdizione di competenza.
5.5
L'esame dei dati forniti dal Ministero dell'Interno e contenuti nelle tabelle riportate nelle pagine successive, mettono in evidenza come nei primi nove mesi del 2000, sulle coste meridionali italiane, siano sbarcati e siano stati successivamente rintracciati 21.245 immigrati. Di questi, provenienti da 50 nazioni, 15.154 (71,3%) sono uomini, 2.443 (11,5%) sono donne e 3.648 (17,2%) sono minori.
Nel 1999, in Puglia, Calabria e Sicilia, erano giunti 49.999 immigrati, provenienti da 61 nazioni (71). Disaggregando i dati, si può notare come 22.486 (45%) erano uomini, 10.962 (21,9%) erano donne e 16.551 (33,1%) erano minorenni.
Una comparazione dei dati generali, mette in evidenza come tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI vi sia stata una drastica diminuzione delle persone che hanno tentato di introdursi illegalmente attraverso le coste meridionali nel territorio italiano. La Puglia, pur rappresentando la prima regione per numero di immigrati giunti via mare, non risulta più essere la regione degli sbarchi, come nel 1999, ma la regione in cui approdano la maggior parte degli immigrati che i trafficanti cercano di introdurre in Italia utilizzando la via marittima. Infatti, se nel 1999, nella regione del «tacco d'Italia» erano giunti 46.481 persone, pari al 93% del totale degli sbarcati nel meridione d'Italia, al settembre di quest'anno gli arrivi risultano pari a 14.157, il 66,6% del totale sbarcati, facendo registrare consistenti diminuzioni sia negli uomini, che nelle donne e nei minori.
Diversa è invece la situazione per la Calabria, dove si registra un significativo aumento del numero degli immigrati sbarcati e successivamente rintracciati. Infatti, se nel 1999, in Calabria erano giunti 1.545 immigrati, pari al 3,1% del totale sbarcati, nei primi nove mesi del 2000, sono approdati, soprattutto sulle coste reggine e crotonesi, 5.041 immigrati, il 23,7% del totale degli sbarcati giunti sulle coste meridionali italiane. La Calabria è divenuta anch'essa una terra di sbarchi di massa. In particolare, durante il periodo marzo-settembre
2000, le coste calabresi sono state meta di 16 sbarchi, effettuati da 14 motonavi e da due motopescherecci, provenienti, tranne che in un caso, dai porti turchi di Sarcony, Izmir, Canakkale e Smirne. Complessivamente, questi natanti hanno trasportato in Calabria 5.002 immigrati, la maggior parte dei quali curdi; 63 persone sono state successivamente arrestate. Il numero più frequente di sbarchi si è registrato nel mese di maggio, con cinque sbarchi in 19 giorni mentre, dal punto di vista quantitativo, il più alto numero di immigrati è giunto il 20 luglio nel porto di Reggio Calabria (Motonave «Sam», 552 immigrati), il 23 settembre a Steccato di Cutro (KR) (Motonave «Nilderya», 533 immigrati) e l'11 maggio a Botricello (RC) (Motovave «Venus Star», 475 immigrati).
La Sicilia ha visto passare il numero degli immigrati sbarcati sulle sue coste, in particolare nell'agrigentino, nel ragusano e nel trapanese, da 1973, nel 1999 (il 3,1% del totale sbarcati) a 2.047 (il 9,6% del totale sbarcati) nel 2000. L'analisi dei dati, mette in evidenza come a fronte di un incremento del numero degli uomini, si registri una forte diminuzione del numero delle donne e dei minori.
Effettuando un'analisi qualitativa della composizione dei flussi migratori, attraverso l'utilizzo delle prime dieci nazionalità degli immigrati sbarcati sulle coste meridionali italiane, si può notare come nel 1999 la Puglia abbia costituito il punto di approdo per molti immigrati provenienti dall'area balcanica e, in modo particolare, dal Kosovo, a quel tempo alle prese con un aspro conflitto bellico iniziato il 24 marzo 1999 e terminato il 10 giugno successivo.
Nel corso del 2000, le coste pugliesi sono state la meta principale di due grandi flussi migratori costituiti, da una parte, dagli immigrati provenienti dalla regione balcanica, in modo particolare dall'Albania, dall'altra, da immigrati curdi, provenienti dall'Iraq e dalla Turchia; sia per il primo flusso che per il secondo si registra una diminuzione rispetto ai dati del 1999.
I dati, inoltre, evidenziano come sulle coste pugliesi siano giunti immigrati provenienti dal Sub-Continente indiano e dalla Cina e come i cinesi risultino in aumento rispetto al 1999.
Le coste calabresi, sia nel 1999 che nei primi mesi del 2000, sono state meta soprattutto di flussi migratori composti da immigrati curdi, provenienti dalla Turchia e dall'Iraq; altri immigrati approdati in Calabria provengono dal Sub-Continente indiano, dai paesi arabi e dall'Africa.
Le coste siciliane rappresentano la meta dei flussi migratori provenienti dal continente africano, in particolare dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Tra i paesi nord-africani, quelli dai quali traggono origine i flussi migratori più consistenti sono il Marocco, la Tunisia e l'Algeria; altri immigrati, in misura nettamente inferiore, provengono dal Sub-Continente indiano e dai paesi arabi.
Comparando i dati del 1999 con quelli dei primi nove mesi del 2000, si possono rilevare ulteriori particolarità, come ad esempio le regioni in cui sono arrivati esclusivamente solo uomini o solo donne e in quale delle tre regioni meridionali considerate sono arrivati esclusivamente immigrati provenienti da determinate nazioni.
Per quanto riguarda il primo punto, si può rilevare che un'immigrazione esclusivamente maschile caratterizza sia la Puglia, che la Calabria e la Sicilia. Quest'ultima, sia nel 1999 che nel 2000 è stata la meta per uomini provenienti dai paesi africani (Guinea, Libia, Liberia, Mauritania, Senegal, Sierra Leone, Sudafrica, Somalia, Zaire e Zambia) dal Sub-Continente indiano (Afganistan, Bangladesh, India, Pakistan, Sry Lanka), dai paesi arabi e medio orientali (Giordania, Iran, Yemen) e dai paesi asiatici (Malesia).
La Calabria, tra il 1999 e il 2000, ha visto aumentare il numero delle nazionalità dalle quali provengono i flussi migratori maschili che giungono sulle sue coste. Infatti, se nel 1999 gli uomini arrivavano dai paesi africani (Algeria, Burkina Faso, Costa d'Avorio ed Egitto) nel 2000 essi sono arrivati soprattutto dal Sub-Continente indiano (Bangladesh, India, Pakistan), oltre che dai paesi arabi (Iran) e da più paesi africani (Mauritania, Ruanda, Senegal, Somalia, Tunisia) oltre a quelli già menzionati in precedenza.
In Puglia, l'immigrazione esclusivamente maschile proviene soprattutto dal Sub-Continente indiano (India, Pakistan), oltre che dall'Africa (Algeria, Libia, Mozambico, Senegal, Sudafrica), dall'Europa orientale (Kazakistan e Russia), dall'Asia (Malesia) dai paesi arabi (Palestina).
Quest'ultima regione, si caratterizza per essere l'unica nella quale arrivano, seppur in misura nettamente inferiore rispetto agli uomini, i flussi migratori esclusivamente femminili. Le donne, molte delle quali oggetto di sfruttamento sessuale, arrivano in Puglia dall'America Latina (Colombia, Perù), dall'Africa (Ghana, Liberia, Nigeria), dall'Europa dell'Est (Georgia, Kazakistan, Moldavia,) e dalla ex Jugoslavia (Slovenia).
Infine, i dati ministeriali indicano chiaramente come dalle nazioni in guerra e da quelle in cui vigono persecuzioni di tipo razziale, religioso e politico, fuggano interi nuclei familiari (es. kosovari e curdi).
In relazione alla nazionalità di provenienza degli immigrati sbarcati in modo esclusivo in una delle tre regioni meridionali italiane oggetto di sbarchi, si può notare come:
in Puglia, nel 1999 sono sbarcati immigrati provenienti: dalla Bulgaria, dalla Croazia, dalla Jugoslavia, dalla Malesia, dal Mozambico, dalla Polonia, e dal Sudafrica, mentre nel 2000 sono arrivati immigrati dalla Birmania, dalle Filippine, dalla Georgia, dalla Slovenia e dallo Zambia. In entrambi gli anni, gli immigrati giunti esclusivamente in Puglia sono provenuti: dalla Bosnia, dalla Cina, dalla Colombia, dal Montenegro, dalla Serbia, dal Kazakistan, dalla Macedonia, dalla Moldavia, dalla Nigeria, dal Perù dalla Romania e dall'Ucraina, a testimonianza di come l'Albania, oltre ad essere un territorio dove si organizzano i traffici, sia anche diventata un luogo di raccolta di flussi migratori provenienti da diversi continenti (Est Europa, Africa, Cina, America Latina) e di come la malavita albanese abbia, come già evidenziato in precedenza, contatti con la mafia cinese, turca e russa. Inoltre, come si può notare confrontando i dati sugli sbarchi con quelli inerenti l'applicazione dell'articolo 18 T.U. 286/98, alcuni paesi di provenienza degli immigrati, corrispondono a quelli dai quali provengono le giovani donne costrette all'esercizio coatto della prostituzione
in Italia, a testimonianza di come la malavita albanese gestisca, secondo quanto riferito dagli inquirenti ed evidenziato dai dati ministeriali (Tab. n. 26), in modo quasi monopolistico questo mercato criminale e, in esso, ragazze non solo albanesi, ma anche provenienti dall'Europa Centro-Orientale e dal continente africano (72);
sulle coste calabresi, solo nel 1999, sono giunti in forma esclusiva immigrati provenienti dal Burkina Faso e dalla Costa d'Avorio;
sulle coste siciliane, nel 1999, sono giunti in forma esclusiva immigrati provenienti dalla Guinea, dal Kenya e dalle Maldive, mentre nel 2000 sono giunti immigrati dalla Giordania e dallo Yemen. Sia nel 1999 che nel 2000, in Sicilia sono arrivati immigrati provenienti dal Libano.
In conclusione, si può notare come l'aumento del numero delle persone sbarcate in Calabria e in Sicilia, unitamente alla scoperta di sbarchi avvenuti anche sulle coste del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e della riviera romagnola (Ravenna), dimostrino che tra il 1999 e i primi nove mesi del 2000, le rotte marittime utilizzate dai trafficanti si sono in parte modificate, spostandosi verso la fascia medio-alta del litorale adriatico e verso le coste meridionali calabresi e siciliane non sottoposte a particolari controlli come quelle pugliesi (73).
Tab. 3

Tab. 4
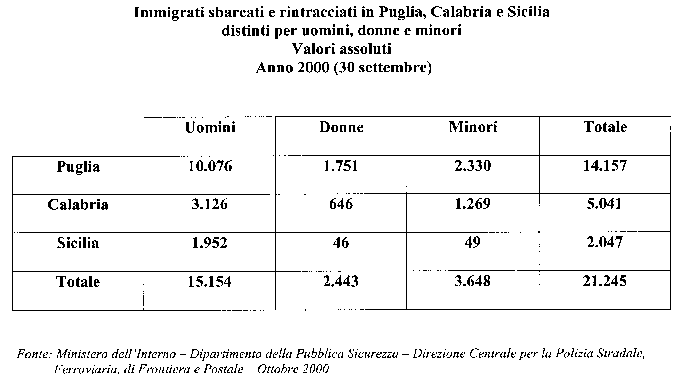

Tab. 5

Tab. 6


Tab. 7

Tab. 8

Tab. 9

Tab. 10

Tab. 11

Tab. 12

Tab. 13




Tab. 14

5.6 Altri punti d'entrata (74).
I flussi migratori irregolari entrano nel territorio italiano anche attraverso altre zone oltre a quelle indicate nei paragrafi precedenti.
Nel nord Italia, ad esempio, oltre al confine italo-sloveno, una porta d'ingresso nella penisola italiana è costituita dal confine italo-francese, particolarmente utilizzato da immigrati nordafricani e dell'Africa Sub subsaharina, entrati clandestinamente in Europa attraverso lo stretto di Gibilterra; a fianco di questi immigrati, in misura minore, si riscontra la presenza di persone provenienti dal Sub-Continente indiano, dall'Europa orientale e dalla regione balcanica.
L'entrata nel territorio italiano viene effettuata utilizzando mezzi di trasporto, pullman o veicoli commerciali, dotati di apposite modifiche per nascondere gli immigrati.
L'entrate attraverso il confine italo-francese è utilizzata dai trafficanti anche per introdurre giovani donne nigeriane da utilizzare nel mercato dello sfruttamento della prostituzione (75).
Tab. 15
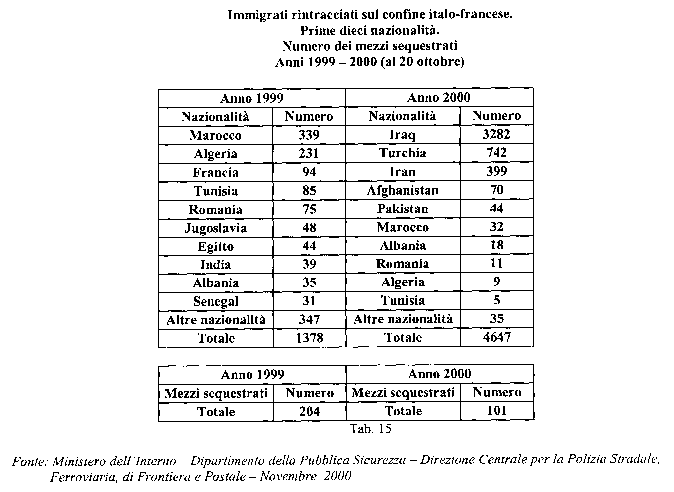
I dati forniti dal Ministero dell'Interno (Tab. n. 15), oltre ad evidenziare un significativo aumento del numero dei rintracci alla frontiera italo-francese, mettono in evidenza come durante il 2000 sia aumentato il numero dei rintracci di immigrati provenienti dall'Iraq, dall'Iran e dalla Turchia. Nella maggioranza dei casi, si tratta di immigrati curdi che transitano dall'Italia verso i paesi dell'Europa centrale, in particolare la Germania.
I dati relativi ai confini italo-sloveno ed italo-francese, vanno indubbiamente messi in relazione all'aumento del numero degli sbarchi e dei rintracci di immigrati curdi e di quelli provenienti dal Sub-Continente indiano effettuati sulle coste della Calabria.
Il confine italo-svizzero e quello italo-austriaco sono anch'essi utilizzati da immigrati intenzionati ad entrare nel territorio italiano, in particolare da quelli provenienti dal Nord Africa, dalla regione balcanica, dal Sub-Continente indiano, dall'Estremo Oriente e dal Sud America.
Nonostante la varietà delle nazionalità, i confini con la Svizzera, con l'Austria e con la Francia sono utilizzati dai migranti soprattutto per transitare verso altri paesi europei o extraeuropei, come ad esempio i curdi, e solo in misura minore per entrare in Italia (76).
6.
L'analisi del contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina si basa su una serie di indicatori ben definiti, tra i quali compaiono innanzitutto il numero delle persone denunciate ed arrestate per aver favorito, come previsto dall'articolo 12 del T.U. 286/98, l'ingresso ed il soggiorno illegale di immigrati nel territorio nazionale.
Nel 1999 e nei primi nove mesi del 2000, il numero delle persone denunciate per i reati poc'anzi accennati, è stato rispettivamente di 848 e di 646; il numero degli arrestati è stato di 889 nel 1999 e di 723 fino al 26 settembre dell'anno in corso.
Tra le prime dieci nazioni che presentano sia persone denunciate che arrestate per i reati di cui all'articolo 12, T.U. 286/98, troviamo: l'Italia, l'Albania, la Romania, la Slovenia, la Jugoslavia, il Marocco e la Cina popolare.
Gli italiani e gli albanesi occupano i primi posti tra i denunciati e gli arrestati, con la differenza che gli autoctoni primeggiano nella prima categoria, facendo registrare un numero di denunce di 231 nel 1999 e di 154 nel 2000, mentre gli albanesi primeggiano nella categoria degli arrestati, passando dai 214 del 1999, ai 172 del 2000.
Gli albanesi, inoltre, unitamente ai cinesi, hanno visto aumentare il numero delle persone denunciate, passato, per i primi, dai 118 casi del 1999 ai 125 del settembre 2000, mentre per i secondi si è passati dai 39 casi dell'anno appena trascorso ai 67 del 2000. I cinesi, inoltre,
registrano un trend in rapida ascesa del numero delle persone arrestate, che dalle 43 del 1999, sono passate a 76 nei primi nove mesi del 2000.
Un altro caso che merita di essere segnalato è quello dei cittadini rumeni che, se da un lato vedono diminuire il numero delle persone denunciate, passando dalle 70 del 1999 alle 40 del 2000, dall'altro registrano un aumento nella quantità delle persone arrestate, che passano dalle 64 dell'anno appena trascorso alle 75 di quello in corso.
Un altro indicatore che viene utilizzato per illustrare il grado e le modalità di contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina è l'analisi dei dati inerenti gli arresti dei trasportatori e quelli relativi ai mezzi sequestrati.
Come si vede dalla tabella 18, il confronto tra i dati del 1999 e quelli del 2000, mettono in evidenza una serie di aspetti, alcuni dei quali sono già stati illustrati nelle pagine precedenti.
Nel 1999 sono stati arrestati complessivamente 350 trasportatori, mentre al mese di settembre dell'anno in corso il loro numero corrisponde a 231.
La Puglia si conferma la regione in cui si riscontra il maggior numero di trasportatori arrestati. I dati forniti indicano in 327 le persone arrestate nel 1999 (il 93,4% sul totale annuale) e in 144 quelle per l'anno in corso (62,3% sul totale annuale) (77).
In relazione alla Calabria e alla Sicilia che, come è stato precedentemente affermato, hanno visto aumentare il numero degli immigrati che giungono sulle loro coste, si riscontra un significativo aumento del numero di trasportatori arrestati, in particolare per la prima regione. In Calabria, infatti, si è passati dai 6 arresti del 1999 ai 64 del 2000, mentre per la Sicilia si registra un leggero aumento che vede gli arresti aumentare da 17 a 21.
Un dato significativo, per il 2000, è che arresti di trasportatori sono stati effettuati anche in altre regioni italiane, a conferma ulteriore di come le rotte utilizzate per introdurre gli immigrati nel nostro Paese abbiano subito delle modifiche.
In relazione ai mezzi utilizzati per introdurre illegalmente gli immigrati nel nostro Paese, i dati forniti (Tab. 18) illustrano che nel 1999 il numero dei sequestri è stato pari a 241 unità, mentre al settembre 2000 gli stessi ammontano a 140 unità, suddivise in 43 veicoli sequestrati (unicamente in Puglia) e in 97 natanti, il cui sequestro è avvenuto in 37 casi in Puglia, in 18 casi in Calabria, in 41 casi in Sicilia e in un solo caso in un'altra regione italiana non specificata.
Infine, come ultimo indicatore del livello di contrasto all'immigrazione clandestina, si considera il numero degli immigrati che, in base alle leggi vigenti, sono stati oggetto di un provvedimento di respingimento o di esplusione.
Nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 30 settembre 2000, gli stranieri allontanati dal territorio nazionale sono stati 49.162, quelli
intimati sono stati 44.046 e quelli immessi nei centri di permanenza temporanea sono stati 7.005, di cui 820 sono ancora attualmente nei centri.
Nel 1999, relativamente alle stesse categorie di dati, si può rilevare come gli stranieri allontanati dal territorio nazionale siano stati complessivamente 72.392, di cui la maggior parte è stata respinta alla frontiera (36.937 casi) o esplusa mediante l'accompagnamento ad essa (12.036 casi).
In forma più analitica, e per l'anno in corso, si può constatare come tra gli stranieri complessivamente allontanati, la maggior parte (24.317 casi) sono stati respinti alla frontiera o accompagnati ad essa (10.303 casi), mentre in altri casi i provvedimenti di respingimento e di esplusione sono stati emessi dai Questori (8.556 casi) o dall'Autorità giudiziaria (220 casi); infine, un rilevante numero di persone immigrate è stato espulso dal territorio italiano, mediante gli accordi di riammissione stipulati con i paesi di provenienza.
Il numero degli stranieri a cui, sino al 30 settembre 2000, è stato consegnato un decreto di espulsione e concesso un tempo di 15 giorni per lasciare il territorio italiano (cosiddetti intimati) è risultato maggiore di 3.557 unità rispetto al 1999, a differenza del numero degli stranieri complessivamente allontanati, il cui totale complessivo dell'anno ancora in corso, risulta inferiore rispetto a quello dell'intero 1999.
Tab. 16

Tab. 17
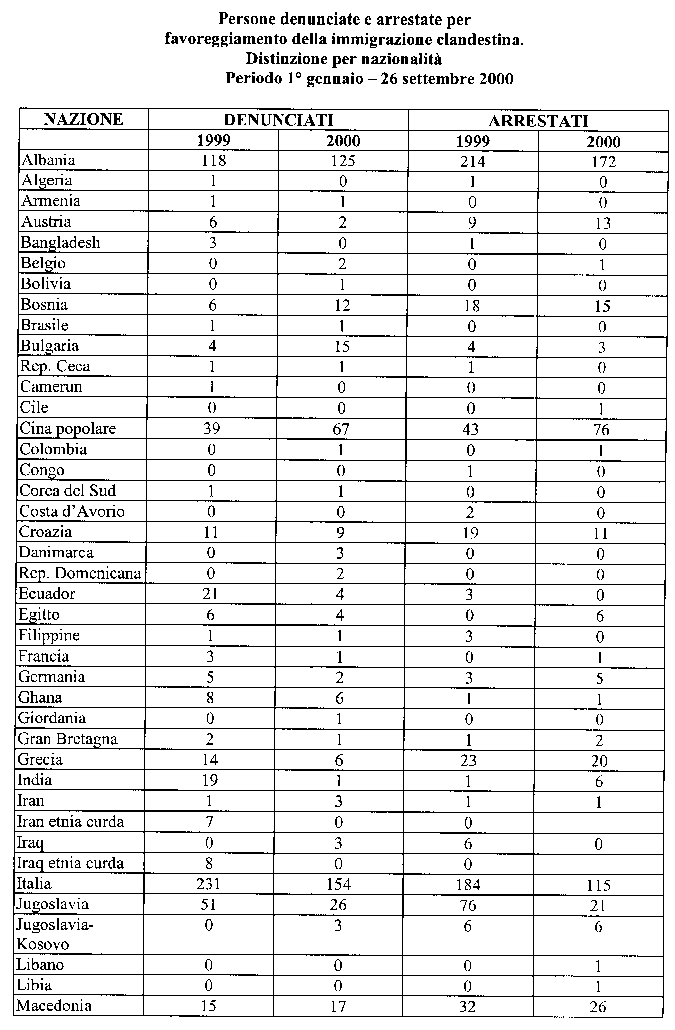


Tab. 18

(78) I dati forniti dal Ministero dell'Interno per l'anno 1999 non sono disaggregati come per il 2000, tra veicoli e natanti sequestrati. Le cifre attestano soltanto che nel 1999 sono stati sequestrati 198 mezzi in Puglia, 6 in Calabria e 37 in Sicilia.
Tab. 19
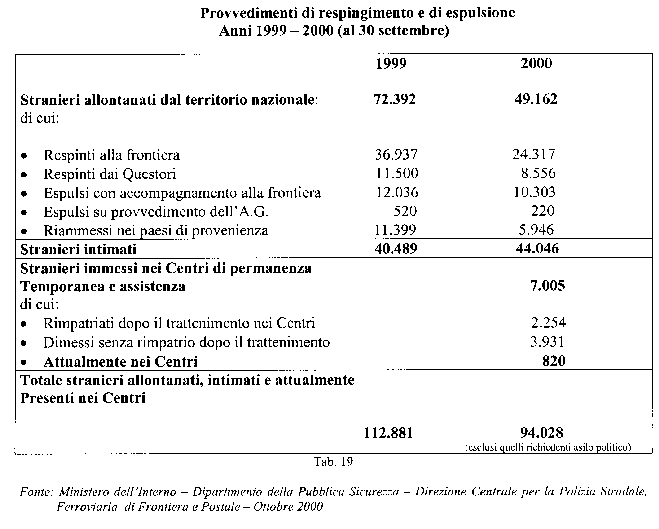
7. I mercati dello sfruttamento delle persone trafficate.
Come il Comitato ha avuto modo di constatare sia durante le audizioni che nell'esame degli atti giudiziari acquisiti, le persone oggetto di tratta sono principalmente sfruttate all'interno di specifici mercati illeciti, tra i quali, principalmente, quello del lavoro nero, quello della prostituzione da strada e, soprattutto in relazione allo sfruttamento dei minori, quello dell'accattonaggio.
Il trafficking, infatti, è finalizzato allo sfruttamento economico del trafficato da parte del trafficante il quale, per raggiungere questo obiettivo, si avvale dell'utilizzo di determinati «strumenti», che possono essere individuati nella violenza, nel ricatto e nell'inganno.
Il trafficante può essere rappresentato sia dalla stessa persona che ha provveduto al trasporto del migrante sia da colui, definito come «committente», che paga un trasportatore criminale per poter successivamente disporre di manodopera irregolare, di manovalanza criminale ovvero di un «prodotto» particolarmente richiesto su determinati mercati illeciti presenti nel paese di destinazione.
Le ragioni che inducono le persone immigrate a divenire - in alcuni casi anche consensualmente (es. immigrati cinesi) - oggetto di sfruttamento all'interno di determinati mercati, sono molteplici e riguardano non soltanto i migranti arrivati in Italia clandestinamente o irregolarmente, ma anche persone giunte regolarmente o in modo non coattivo.
Per comprendere questo fenomeno, occorre partire dalla constatazione che, come già ricordato, vi sono persone che decidono esse stesse di emigrare ed altre, invece, che lo sono costrette con la violenza, il ricatto e l'inganno. Tra le prime, rientra anche un segmento di persone che emigrano senza disporre di alcun capitale, mobile o immobile, proprio, né possono contare sull'aiuto di una comunità o di reti sociali alternative disposte a farsi carico delle loro spese di viaggio e delle loro ulteriori necessità una volta raggiunto il paese di destinazione. Tuttavia, il desiderio ovvero la necessità di emigrare, spingono alcuni immigrati a rivolgersi a criminali specializzati in trasporti e introduzioni illecite in paesi sviluppati, con i quali essi stabiliscono un contratto di trasporto, il cui costo sarà risarcito ratealmente, mettendo volontariamente a disposizione dei trafficanti il proprio corpo o la propria forza fisica, in mancanza d'altro.
Alla base di questa decisione, si possono trovare due elementi principali: da una parte, lo stato di necessità, che connota il processo migratorio non come una libera scelta, ma come una costrizione imposta da ragioni oggettive ed ambientali (es. povertà, persecuzione per motivi politici, di razza, di religione); dall'altra, la convinzione - spesso errata - che la condizione di sfruttamento alla quale volontariamente alcuni immigrati accettano di sottoporsi, sia legata ad una fase temporale ben delimitata nel tempo.
Nel caso della consensualità allo sfruttamento, si incontrano distinti e reciproci interessi, sia da parte del trafficante che del trafficato. Infatti, il primo ha la possibilità di disporre non di una persona, ma di una «merce» con cui può realizzare un ingente profitto attraverso il suo uso, la sua compravendita o il suo scambio con altre merci o
servizi illeciti. L'immigrato, invece, subordina lo sfruttamento ad una serie di fattori, tra i quali si possono menzionare: la possibilità di raggiungere la «terra della speranza», la possibilità di poter godere di una determinata protezione, soprattutto in caso di clandestinità o irregolarità, la possibilità di poter percepire un reddito con il quale poter saldare gradualmente il debito contratto e contribuire a mantenere se stesso e la sua famiglia, la possibilità di poter accumulare un capitale che gli consenta di tornare in patria e là di investirlo in una determinata attività professionale. L'accettazione dello sfruttamento, inoltre, in alcuni casi è subordinata anche alla possibilità di poter attendere un provvedimento di regolarizzazione all'interno del paese di destinazione.
In molti altri casi, lo sfruttamento è forzato ed è attuato attraverso l'utilizzo della violenza, del ricatto e dell'inganno.
Questi tre «strumenti» dei quali, in alcuni casi, i trafficanti si avvalgono anche nella fase di reclutamento e di trasporto dei migranti, consentono loro di disporre totalmente di schiavi dai quali possono trarre un beneficio economico notevole a fronte di costi e di rischi penali piuttosto ridotti rispetto ad altri tipi di traffici illeciti.
L'utilizzo della violenza, del ricatto e dell'inganno si riscontra soprattutto nel mercato della prostituzione da strada, gestito prevalentemente dai clan malavitosi albanesi e nigeriani, e nel mercato del lavoro forzato, soprattutto in quello che vede impiegati gli immigrati cinesi.
Queste tre modalità di instaurazione e mantenimento di una relazione tra trafficante e trafficato, vengono usate sia nei confronti dei migranti sia confronti dei loro familiari in patria.
In particolare, la violenza, fisica, psichica e sessuale, il ricatto e l'inganno, vengono utilizzati per diverse finalità, tra le quali:
espropriare completamente le persone della propria autonomia psico-fisica e della propria dignità, sino a ridurle in uno stato di schiavitù
punire e dissuadere da eventuali tentativi di fuga o di collaborazione con le forze dell'ordine
sanzionare il mancato raggiungimento di un guadagno o di un altro target giornaliero prestabilito
punire e dissuadere l'eventuale resistenza alla cessione ad altri trafficanti agenti negli stessi mercati, ma in territori diversi, ovvero agenti in diversi mercati
risolvere possibili conflitti tra sfruttato e sfruttatore
garantire un comportamento omertoso che consenta ai trafficanti di godere impunemente dei propri profitti illeciti.
In concreto, la violenza e il ricatto vengono attuati minacciando:
di non restituire i documenti ritirati una volta giunti nel paese di destinazione
di usare concretamente la violenza nei confronti degli immigrati o dei loro familiari
di denunciare gli immigrati alle autorità del paese di destinazione per l'espulsione
di prevedere la concretizzazione di maledizioni previste da riti tribali.
L'inganno costituisce un terzo elemento fondamentale, assieme alla violenza e al ricatto, per instaurare una relazione tra trafficante e trafficato e per cementarla. Le principali azioni, attraverso le quali si ingannano gli immigrati-trafficati sono:
la falsa promessa di poter svolgere un determinato lavoro regolare e ben retribuito nel paese di destinazione
la falsa promessa di svolgere quel determinato lavoro in determinate condizioni
l'instaurazione di falsi rapporti di fidanzamento e la falsa promessa di celebrazione di matrimoni
il dover pagare spese di viaggio inizialmente sconosciute ovvero pattuite in misura inferiore rispetto a quanto richiesto a destinazione
l'essere portati in un paese diverso da quello promesso o pattuito
l'essere informati in modo completamente errato sulla legislazione vigente in materia di immigrazione nel paese di destinazione e sui comportamenti delle forze dell'ordine
l'essere informati in modo erroneo sulle reali possibilità di trasporto presenti nel paese di destinazione
l'essere falsamente informati sulle condizioni di vita e di salute dei propri familiari in patria
la minaccia, nel caso delle giovani donne costrette alla prostituzione, di inviare ai parenti in patria foto o videocassette compromettenti e rivelatrici della triste realtà vissuta nel paese di destinazione.
A tutto questo, si aggiunga che molti immigrati non conoscono la lingua, il contesto sociale e culturale del paese di destinazione, in quanto non è loro permesso di allontanarsi da quei luoghi nei quali sono controllati a vista giorno e notte dai trafficanti o dai «committenti». Inoltre, molte persone trafficate, credono ciecamente alle parole dei loro sfruttatori in quanto, ad esempio, hanno già vissuto delle esperienze di sfruttamento precedenti o arrivano da paesi in cui effettivamente il tasso di corruzione delle forze dell'ordine è molto elevato.
In conclusione, è necessario porre in evidenza il fatto che l'attuazione di modalità violente, ricattatorie e ingannevoli finalizzate allo sfruttamento sessuale o del lavoro forzato di persone immigrate non risulta essere compiuta soltanto da criminali stranieri, ma anche da
parte di italiani e, in particolare, da persone addette al controllo dei documenti, dell'ordine pubblico o dei biglietti di viaggio all'interno di mezzi pubblici (79).
7.1 Il lavoro nero.
Il lavoro nero rappresenta uno dei principali mercati nei quali vengono inseriti gli immigrati oggetto di sfruttamento. Infatti, le organizzazioni di trafficanti di alto e medio livello sono in grado di fornire, assieme al trasporto e all'introduzione illegale nel paese di destinazione, anche un servizio di intermediazione per la manodopera, ex ante o ex post che, per una persona priva molto spesso di documenti di identità, di un capitale proprio, di un vitto e di un alloggio minimi, rappresenta una risorsa estremamente importante. Infatti, la possibilità di poter lavorare e quella di poterlo fare in modo nascosto, in alcuni casi anche all'interno di una comunità di connazionali presenti nel paese di destinazione - come avviene per i cinesi - consente alla persona trafficata sia di percepire un reddito con il quale pagare il proprio debito per il trasporto e l'introduzione in Italia, sia di poter usufruire di una protezione (80) nei confronti di eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine che, nel peggiore dei casi, potrebbero portare alla sua espulsione e, quindi, alla perdita totale dell'investimento effettuato per emigrare.
L'aumento dei flussi migratori, non costituisce la causa della nascita del lavoro nero e dell'economia informale in Italia. Infatti, già prima dell'aumento dei flussi migratori verso il nostro Paese, il lavoro nero ha costituito una caratteristica strutturale dell'economia italiana. Con l'aumentata mobilità delle persone, provenienti dai paesi in via di sviluppo o in transizione, il bacino di manodopera disposta ad accettare bassi salari, orari di lavoro prolungati, lavori pesanti svolti in condizioni prive dell'idonea sicurezza e, naturalmente, senza alcuna tutela previdenziale, si è allargato oltre i confini nazionali.
L'economia informale italiana, dunque, costituisce di per sé uno dei fattori di attrazione dei flussi migratori irregolari verso il nostro Paese (81). Infatti, per molte persone straniere che giungono in Italia prive di documenti di riconoscimento e di un capitale proprio, nonché per gli immigrati che, al contrario, sono giunti in modo regolare e con risorse proprie, il mondo del lavoro nero consente di guadagnare, in alternativa al compimento di azioni delinquenziali, un salario necessario per recuperare il proprio capitale investito ed una importante risorsa per far fronte ai propri bisogni primari.
I datori di lavoro dell'economia informale, sono costituiti soprattutto da aziende di piccole dimensioni, spesso a conduzione familiare, inserite all'interno di un mercato dove il profitto è direttamente legato alla quantità di prodotto realizzato, piuttosto che alla sua qualità.
Si tratta, dunque, di un mercato del lavoro rifiutato da molti italiani, in quanto richiede persone di basso profilo disposte, come abbiamo detto, a lavorare per molte ore al giorno, a percepire un salario inferiore rispetto a quello stabilito dai contratti nazionali ovvero di quello pagato ai lavoratori autoctoni, disposte a lavorare in condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza precarie.
Il lavoro nero richiede soggetti marginalizzati dal mercato del lavoro ufficiale e, sotto certi aspetti, rappresenta un ponte tra attività economiche lecite ed illecite. Infatti, a fronte del percepimento di un salario e di una «protezione» minimi per gli immigrati, l'imprenditore trova conveniente assumere irregolarmente lavoratori stranieri e sfruttarli - alterando in tal modo le regole della concorrenza - perché, in questo modo, egli riduce i costi di produzione, primi fra tutti quelli della manodopera e quelli relativi agli oneri contributivi, aumentando così il proprio profitto.
I settori dell'economia informale, nei quali buona parte degli immigrati clandestini, irregolari e, in alcuni casi, regolari operano in Italia, sono:
i lavori domestici, svolti soprattutto da persone di sesso femminile provenienti dai paesi asiatici ed africani. Si tratta di lavori consistenti soprattutto nella cura della casa e dei soggetti più fragili, come i bambini e gli anziani;
i lavori agricoli, svolti in particolare da persone di sesso maschile, nelle aree meridionali del paese in occasione della stagione di maturazione e di raccolta di determinati prodotti (es. pomodori). In quest'ambito lavorativo si sono riscontrati fenomeni di sfruttamento legati all'esercizio del ricatto o dell'inganno da parte dei cosiddetti «caporali», alcuni dei quali stranieri essi stessi, che stabiliscono giornalmente chi assumere e con quale salario (82).
i lavori edili, in particolare quelli afferenti alla manovalanza;
i lavori nel settore della ristorazione, nei laboratori di pelletteria e tessili, svolti soprattutto da immigrati cinesi, costretti a vivere e a lavorare anche per 12-13 ore al giorno, sette giorni su sette, negli stessi luoghi, in condizioni precarie dal punto di vista igienico-sanitario (83);
i lavori ambulanti, svolti da immigrati provenienti soprattutto dal continente africano (in particolare dal Senegal) e, da qualche anno, anche da immigrati asiatici (in particolare i cinesi). I lavoratori ambulanti sono molto mobili e rappresentano l'aspetto più visibile del lavoro nero o dell'economia informale. Essi, all'interno delle città e nei luoghi di villeggiatura, vendono prodotti caratteristici dei loro paesi ovvero oggetti di marca falsificati, fabbricati da imprenditori italiani (84), in alcuni casi collegati con la criminalità organizzata. In questo
modo, come nel caso dello spaccio al minuto di sostanze stupefacenti, il rischio del compimento di un'azione illecita, viene scaricato interamente sull'immigrato, nei confronti del quale - in applicazione delle leggi vigenti - le forze dell'ordine possono stabilire di requisire la merce e/o di emettere un decreto di espulsione, anche in sostituzione di una condanna di un tribunale, mentre ben più difficile, sin qui, si è dimostrata l'azione di contrasto nei confronti dei centri di produzione autoctona che su queste attività lucrano ingenti profitti.
Rispetto ad altri tipi di mercato che si analizzeranno nella pagine successive, le relazioni esistenti tra trafficante o «committente» e persona trafficata, si fondano prevalentemente su quello che precedentemente abbiamo definito uno sfruttamento consensuale. Più che la violenza, peraltro non completamente assente, in questo tipo di mercato, le persone vengono sfruttate attraverso modalità riconducibili all'inganno e al ricatto, mediante, ad esempio, la minaccia di non restituire i documenti requisiti fino all'estinzione completa del debito, la minaccia di esercitare azioni violente nei confronti dei familiari in patria, il retribuire con un salario nettamente inferiore rispetto a quello pattuito o, infine, nel far svolgere il lavoro promesso in forme assolutamente diverse da quelle concordate.
7.2 La prostituzione.
Il mercato della prostituzione rappresenta la più nota e visibile attività di sfruttamento di cui sono oggetto numerose donne, spesso minorenni, provenienti soprattutto dall'Europa Centro-Orientale, dall'Africa, dell'Asia e dell'America Latina. Naturalmente, non si deve commettere l'errore di considerare l'insieme delle donne trafficate come coincidente con l'insieme delle donne straniere che in Italia esercitano la prostituzione in forma autonoma. Inoltre, è opportuno considerare che una parte delle donne provenienti da paesi esteri viene sfruttata anche in altri tipi di mercato diversi dalla prostituzione (es. la schiavitù domestica) e che, un'altra parte di quelle che esercitano il meretricio, sono giunte nella nostra penisola attraverso le vie legali.
Come si può osservare dalle tabelle n. 20 e n. 24, nel corso degli anni '90 il numero dei delitti e quello delle persone denunciate per i reati inerenti la prostituzione, hanno mostrato un trend di crescita, passando per i reati da 1.192 casi del 1990 a 2.497 casi nel 2000 (+ 109,5%) e, per le persone denunciate, da 1.291 casi a 2.941 (+ 127,8%).
Prendendo in considerazione la distribuzione per aree geografiche delle denunce inerenti i delitti di prostituzione, nell'arco temporale 1996-1999, si può osservare (Tab. n. 21 e 22) come il Nord ed il Centro Italia occupino rispettivamente il primo (50% delle denunce nel 1999) ed il secondo posto (28% delle denunce nel 1999), a conferma di come l'infiltrazione ed il radicamento dei gruppi stranieri, soprattutto albanesi e nigeriani, che gestiscono questo mercato, siano avvenuti soprattutto all'interno di regioni ricche che, a differenza delle regioni meridionali, non hanno conosciuto storicamente la nascita sul proprio territorio di organizzazioni delinquenziali di tipo mafioso.
Il mercato della prostituzione, in pratica, ha permesso ai gruppi criminali stranieri di accumulare notevoli ricchezze, di occupare spazi criminali lasciati liberi dalle organizzazioni delinquenziali autoctone, di espandere il loro agire criminale in altri mercati illeciti, primo fra tutti quello degli stupefacenti e, conseguentemente, di iniziare una progressiva opera di radicamento sul territorio.
La prostituzione, pur non essendo un fenomeno nuovo, anche in Italia, tra la fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90, ha visto modificare la sua struttura, le sue modalità di esercizio, i suoi attori, in conseguenza della crescita dei flussi migratori.
L'offerta all'interno questo mercato, rappresentata dalle prostitute, ha visto aumentare lungo le strade delle città il numero delle donne straniere provenienti dall'Albania, dalla Moldavia, dalla Ucraina, dalla Romania, dalla Nigeria, oltre che dal continente latino-americano, a fronte di un ritiro all'interno delle abitazioni delle meretrici italiane. La prostituzione da strada, inoltre, si è affermata come un mercato in crescita anche dal punto di vista della domanda, che è stata stimata in nove milioni di italiani, la maggior parte dei quali coniugati (70%), come constatato da alcuni ricercatori (85) e come affermato anche da alcune giovani donne uscite da questa situazione drammatica, che la delegazione del Comitato di lavoro sulla criminalità organizzata internazionale ha avuto occasione di ascoltare durante il sopralluogo nel centro di permanenza temporanea leccese «Regina Pacis».
La prostituzione, come dimostrano le 3.191 telefonate (46,24% del totale) fatte da cittadini al numero verde contro la tratta delle donne istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il numero delle denunce inerenti le relative fattispecie di reato, passate da 1.192 nel 1990, a 2.519 nel 1999 (+ 111,33%), dimostrano come questo fenomeno desti un forte allarme sociale, sotto molteplici punti di vista (86).
Il Comitato, sulla base delle audizioni, della documentazione e dei dati consultati e riportati nelle tabelle delle pagine seguenti, ha avuto modo di constatare come questo mercato di sfruttamento delle giovani donne sia gestito a livello oligopolistico dai clan malavitosi albanesi e nigeriani, con una netta prevalenza dei primi rispetto ai secondi. Infatti, come si può notare dalla tabella n. 26, nel corso del 1999 il numero dei cittadini albanesi e quello dei cittadini nigeriani occupano rispettivamente il primo e il secondo posto sul totale degli extracomunitari denunciati per reati inerenti la prostituzione, facendo registrare, nel primo caso, un valore di 1.148 denunce (50,3% del totale degli extracomunitari denunciati) e, nel secondo caso, un valore di 192 denunce (8,4% del totale degli extracomunitari denunciati).
Un ulteriore dato a conferma di quanto appena illustrato, sono i risultati del monitoraggio svolto dalla Direzione nazionale antimafia, i cui dati evidenziano come la maggioranza dei 158 procedimenti penali relativi ai reati inerenti la prostituzione, in corso nelle 164
procure italiane dal 1o gennaio 1997 al 1o giugno 1998, veda tra gli imputati stranieri una netta maggioranza dei cittadini albanesi (118 persone su 165 imputati) (87).
Secondo le stime dell'associazione italiana Parsec, il numero delle prostitute straniere presenti in Italia nel 1998 era compreso tra un minimo di 14.765 ed un massimo di 19.289, di cui tra le 7.708 e le 10.130 erano stanziate al nord (soprattutto Lombardia), tra le 5.587 e le 6.989 erano stanziate al centro (soprattutto nel Lazio) e tra le 1.103 e le 1.446 erano presenti tra le regioni del sud e le isole. Circa il 10% dei totali stimati di queste donne sono vittime di tratta (88).
L'esercizio coatto del meretricio è svolto da giovani donne, oggetto di una vera e propria compravendita tra diverse bande criminali, che possono essere gestite direttamente dalle organizzazioni che le hanno reclutate ovvero possono dipendere da un loro «committente» o «protettore», che si è avvalso di un trasportatore criminale per portarle nel paese di destinazione.
A differenza del lavoro nero o dell'economia informale, la delegazione del Comitato recatasi al centro «Regina Pacis», ha avuto modo di constatare direttamente come nel mercato della prostituzione l'utilizzo della violenza, dell'inganno e del ricatto siano molto più frequenti e intensi. Infatti, molto spesso le ragazze sono reclutate mediante il rapimento ovvero mediante l'inganno consistente molto spesso nella promessa di un lavoro dignitoso e ben retribuito nel paese di destinazione, approfittando soprattutto dello stato di particolare povertà in cui vivono e dell'assenza di reali prospettive di miglioramento di vita per il futuro.
Altri sistemi utilizzati per reclutare queste giovani donne consistono nell'instaurazione di falsi rapporti affettivi, cui segue una falsa promessa matrimoniale per il futuro (albanesi), oppure nella sottoposizione a riti magici e tribali che incutono in queste giovani donne vittime della tratta uno stato di vera e propria sudditanza psicologica (nigeriani).
La Presidente del Comitato ha avuto modo di acquisire dai Carabinieri stanziati in Kosovo nell'ambito della HQ KFOR Multinational Specialized Unit, un documento attestante come il reclutamento e il trasferimento in Italia di giovani donne da avviare alla prostituzione - oltre che di immigrati - avvenga anche mediante pseudo agenzie di viaggio che, per una cifra oscillante tra i 1.500 e i 3.000 marchi tedeschi, falsificano i documenti e forniscono il trasporto e l'introduzione nei paesi di destinazione.
L'attività di contrasto svolta in Kosovo dai Carabinieri, ha portato all'arresto di 26 persone e alla liberazione di 41 donne, la maggior
parte delle quali provenienti dall'Europa Centrale e Orientale (Moldavia e Ucraina) (89).
Dopo la fase di reclutamento, sovente queste giovani donne, di cui si va spesso alla ricerca nelle zone rurali, perché più povere materialmente e culturalmente, segue una forma vera e propria di sequestro di persona, nel corso della quale queste ragazze, private dei loro documenti, sono sottoposte a forme di violenza psichica, fisica e sessuale oltre che a ricatti e inganni di ogni tipo, al fine di renderle prive della loro libertà e della loro autonomia di pensiero, di azione, di movimento (90).
Giunte nel territorio di destinazione, ridotte in una vera e propria condizione di schiavitù, le ragazze sono costrette ad esercitare forzatamente l'attività di prostituta in base alle indicazioni, circa i tempi, i costi e i luoghi, fornite loro dai «padroni». L'Interpol ha stimato che una prostituta rende mediamente 120 mila dollari all'anno ai suoi sfruttatori (91); di questi soldi, le ragazze ricevono una parte estremamente irrisoria, che permette loro di mantenersi a stento.
L'esercizio del meretricio viene svolto in uno specifico territorio, in genere lungo strade molto frequentate, in vie periferiche cittadine, vicino ai caselli autostradali, sul quale ciascuna banda criminale esercita la propria sovranità. Gli spazi utilizzati possono essere quelli lasciati liberi dalle organizzazioni criminali autoctone e successivamente conquistati mediante l'esercizio della violenza o dell'intimidazione nei confronti di gruppi criminali rivali, oppure il suolo può essere occupato dopo aver stabilito un accordo con la criminalità organizzata autoctona ed essersi impegnati a corrispondere un compenso monetario prestabilito quale tassa di occupazione di territorio altrui.
Le giovani donne, durante il «turno di lavoro», sono controllate a vista dai loro protettori i quali, oltre a controllare gli incassi in base alla differenza tra i preservativi consegnati a inizio serata e quelli restituiti al termine della stessa, mirano ad evitare possibili tentativi di fuga ovvero possibili contatti con le forze dell'ordine.
Sovente, queste giovani ragazze sono oggetto di compravendita o di scambio tra i vari gruppi criminali, a testimonianza di come la prostituzione straniera sia caratterizzata da un elevato tasso di mobilità, determinato sia dalla richiesta di un rinnovo periodico delle prostitute da parte dei clienti, sia dall'esigenza che gli sfruttatori hanno di salvaguardare la loro impunità, impedendo o ostacolando fortemente la possibilità per queste giovani vittime di instaurare relazioni particolari con alcuni clienti o investigatori che potrebbero portarle alla denuncia e, conseguentemente, all'arresto de loro aguzzini.
A dimostrazione dei rischi che le vittime della tratta per scopi sessuali corrono, si deve considerare l'aumento degli omicidi di donne straniere, in particolare albanesi e nigeriane, compiuti nel nostro Paese, passati dal 6,8% del 1992 al 23,1% del 1999 (26 novembre) (92), sul totale degli omicidi compiuti.
Tab. 20

Tab. 21

Tab. 22

Tab. 23

Tab. 24

Tab. 25
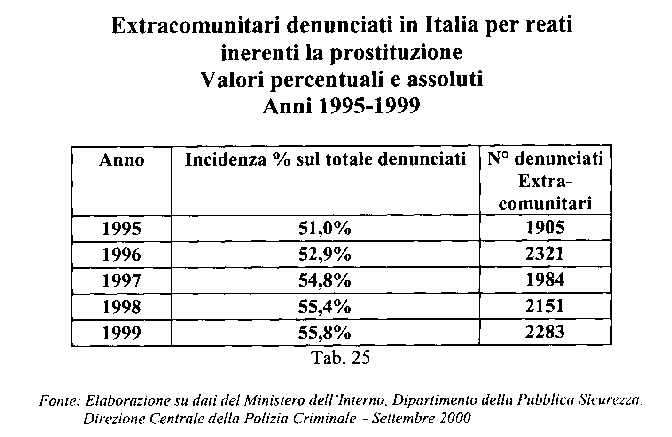
Tab. 26
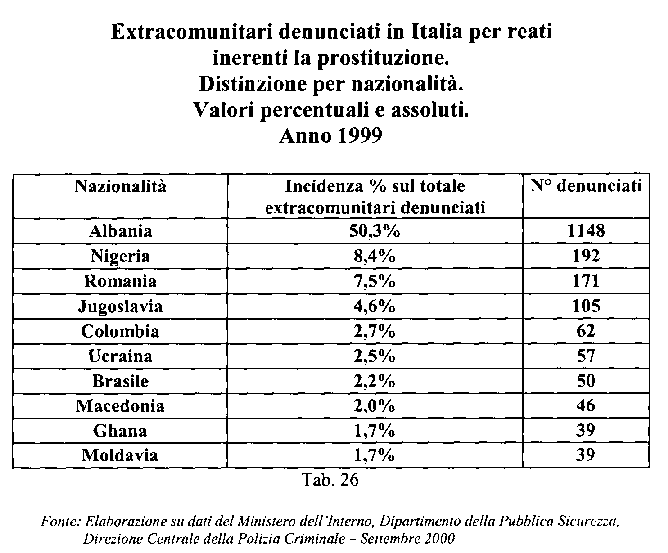
7.3 L'accatonaggio.
L'accattonaggio rappresenta un mercato illecito nel quale sono sfruttati soprattutto i minori di origine slava e albanese, provenienti da famiglie molto numerose ed estremamente disagiate.
La lettura di rassegne stampa specifiche sull'argomento, ha permesso al Comitato di constatare come costantemente il ruolo dello sfruttatore sia rivestito da persone della stessa cittadinanza dei bambini sfruttati (albanesi, slavi, rumeni). Questi ultimi, privati dei loro elementari diritti, costretti a vivere molto spesso all'interno di baracche situate nelle periferie delle città, questi piccoli bambini sono costretti quotidianamente all'esercizio dell'accattonaggio nelle stazioni delle grandi città o agli incroci di strade particolarmente trafficate. Il loro compito è quello di guadagnare quotidianamente una determinata somma, richiedendo un'elemosina ai passanti ovvero cercando di attuare nei loro confronti il furto del portafoglio, della borsa o di un oggetto di particolare valore.
Il mancato raggiungimento della somma prestabilita, così come qualsiasi tentativo di fuga o di ribellione ai propri sfruttatori, viene punito in maniera violenta, in modo tale che il reo ed i suoi compagni capiscano il senso della sanzione e abbandonino qualsiasi tentativo di ricerca della libertà.
Probabili sono le possibilità che questi minori, oltre ad essere oggetto di compravendita o di scambi tra diversi sfruttatori (93), siano sottoposti ad abusi sessuali e, con il passare degli anni, impiegati all'interno di altri mercati illeciti nello svolgimento di attività criminali più evolute.
Indagini svolte dal Comando Regionale Carabinieri della Regione Basilicata hanno avuto modo di accertare che i minori sono utilizzati anche per finalità legate alle adozioni illegali. Nel corso del 1998 e 1999, infatti, sono stati liberati sette bambini albanesi e un bambino bielorusso oggetto di questo turpe traffico (94).
7.4 Il traffico di organi umani.
Il traffico degli organi umani, rappresenta un mercato di sfruttamento del quale, in Italia, non si dispone ancora di prove giudiziarie accertate, ma semplicemente di alcune suggestioni.
Le ipotesi che attendono di essere corroborate da riscontri oggettivi, inducono a pensare che l'espianto di un organo possa costituire una modalità con la quale un immigrato paga una parte ovvero l'intero costo del viaggio dal paese di origine a quello di destinazione, mentre altri sospetti, derivanti dalle confessioni di alcuni passeurs sloveni, spingono a pensare che il prelevamento di parti del corpo umano, operazione particolarmente difficile e delicata, sia compiuta nei confronti
di singoli immigrati che, probabilmente, non dispongono pienamente della capacità di intendere e di volere (95).
Recentemente, nel corso della relazione svolta al convegno internazionale Il traffico degli esseri umani. Alla ricerca di nuove strategie di intervento, organizzato dal Ministero dell'Interno e svoltosi a Roma il 24-25 ottobre 2000, il ministro dell'interno della Repubblica Moldova, Vladimir Turcanu, ha dichiarato la scoperta di 24 casi di cittadini moldavi che, per tremila dollari, sono stati portati in Turchia da esponenti della mafia russa per l'espianto di un rene.
8. Problematiche dell'azione di contrasto investigativo.
Complessivamente, emerge un quadro della concreta esperienza investigativa e processuale segnato da numerose e rilevanti difficoltà.
Il primo e forse più significativo elemento che emerge dalle audizioni (ed obiettivamente confermato dall'esame dei dati raccolti dalla Direzione nazionale antimafia) attiene ad una sorta di obiettiva incapacità dei modelli di qualificazione giuridica delle condotte delittuose prescelti nell'azione investigativa a riflettere le reali connotazioni criminologiche del fenomeno, essendo piuttosto rari i casi nei quali sia formalmente riconosciuta (recte, ipotizzata) l'esistenza di vere e proprie organizzazioni criminali di tipo mafioso ovvero di finalità e metodologie tipicamente mafiose delle specifiche azioni criminose (siano esse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, di sequestro di persona, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di riduzione in schiavitù, di violenza privata), come tali parimenti idonee a dar luogo, ex articolo 51 comma 3-bis c.p.p. allo spostamento della competenza investigativa in capo alle procure distrettuali antimafia, oltre che a rilevanti differenze del trattamento processuale e sanzionatorio degli autori delle medesime.
Grava probabilmente sulle scelte della prassi investigativa non soltanto il peso dell'insufficienza delle basi di ricostruzione della effettiva realtà criminologica di riferimento, ma anche, forse, al di là della consapevolezza delle difficoltà aggiuntive che inevitabilmente ineriscono all'onere di fornire la prova della connotazione mafiosa dell'associazione criminosa o delle sue specifiche manifestazioni illecite, anche alcuni atteggiamenti di obiettiva resistenza ad accentrare negli uffici giudiziari distrettuali la titolarità delle indagini.
È questo un punto cruciale per il positivo orientamento delle politiche di intervento repressivo, apparendo indispensabile impegnare nelle indagini relative a condotte connotate da speciale gravità e da intrinseche proiezioni internazionali sia le risorse e le esperienze delle strutture inquirenti specializzate nelle investigazioni sulla criminalità mafiosa sia le funzioni di raccolta informativa, di impulso e di
coordinamento investigativo istituzionalmente affidate al procuratore nazionale antimafia e che si alimentano anche di contatti e rapporti di collaborazione informativa con autorità straniere tanto essenziali quanto difficili a formarsi in capo a piccoli uffici giudiziari.
L'istruttoria espletata ha, inoltre, consentito di registrare, quasi sempre attraverso la voce dei magistrati e degli investigatori ascoltati, l'esistenza di ulteriori, specifiche difficoltà delle indagini relative al traffico di esseri umani e ai gruppi organizzati di origine straniera che partecipano al controllo dei relativi mercati criminali che acuiscono la debolezza degli sforzi investigativi:
la comprensione delle lingue straniere - quando non dei dialetti - adoperati dai soggetti sottoposti ad indagini, con intuibili rischi e ritardi nella interpretazione e nella traduzione delle comunicazioni intercettate;
la scarsità del numero degli interpreti, la loro l'affidabilità, la necessità di fornire loro una adeguata protezione, anche attraverso la riservatezza del loro apporto (96);
l'insicurezza sulle generalità degli indagati, delle persone offese e degli eventuali testimoni, nonché la loro frequente irreperibilità, con ogni intuibile effetto sul piano dell'acquisizione probatoria (97), anche alla luce delle modificazioni normative connesse alla costituzionalizzazione dei principi del giusto processo;
la difforme applicazione dell'articolo 18 T.U. 286/98.
Il peso effettivo di questi concreti fattori di indebolimento dell'efficacia dell'azione repressiva è naturalmente acuito dalle difficoltà organizzative che, secondo le audizioni e la documentazione raccolta, sembrano caratterizzare stabilmente l'attività degli uffici investigativi in dipendenza:
della scarsità di apparecchiature tecniche e di postazioni per l'effettuazione delle intercettazioni telefoniche su apparecchi cellulari (98);
dei ritardi nella consegna dei tabulati telefonici da parte delle società che gestiscono il servizio e degli stessi limiti temporali nei quali la ricerca investigativa è possibile;
dei ritardi riscontrati nell'espletamento delle rogatorie internazionali e delle difficoltà aggiuntive connesse alla dubbia affidabilità delle strutture di polizia e giudiziarie operanti in Paesi nei quali la credibilità delle strutture statuali deputate alle funzioni di cooperazione internazionale sono minate dalla corruzione, da gravi deficit di professionalità dei funzionari addetti e dalla esiguità delle risorse finanziarie destinate al contrasto della criminalità.
(29) Cfr. A. Bradanini, relazione al convegno Verso la convenzione Onu. Le nuove frontiere della lotta alla criminalità, Torino, 23 aprile 1999, pg. 1.
(30) Procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste, Direzione distrettuale antimafia, Relazione sull'attività del gruppo di lavoro in tema di reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per reati connessi, Anni 1998 e 1999, Trieste, 4 marzo 2000, pg. 12 (Doc. 1831.0).
(31) Cfr. A Pansa, trascrizione della relazione al convegno Il traffico degli esseri umani e il ruolo della criminalità organizzata, cit., pg. 6, in cui si afferma che « [...] addirittura ci sono scuole di lingua italiana nello Sri Lanka in modo tale che il cingalese, che arriva in Italia per la prima volta, dimostra con la conoscenza di poche parole della nostra lingua e di un documento di reingresso falsificato, di essere già stato nel nostro Paese».
I clandestini, inoltre sono forniti di numeri di telefono cellulare di persone a cui si dovranno rivolgere nel corso del viaggio e, in particolare, a destinazione. In alcuni casi, come si è riscontrato, i numeri telefonici sono stati scritti sotto la suola delle scarpe degli immigrati.
(32) Nel caso dell'immigrazione clandestina cinese, specifiche indagini giudiziarie hanno attestato che, nei confronti degli immigrati, sono stati attuati veri e propri sequestri di persona a scopo di estorsione. In alcuni casi, per convincere i parenti di queste persone a pagare il riscatto, sono state fatte loro sentire le urla degli immigrati costretti forzatamente a combattere tra di loro a testate. Nello specifico cfr. Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Trieste, Richiesta per l'applicazione della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di LONCARIC Josip + 53 (Doc. 2038.2)
(33) Il prezzo pattuito può comprendere anche un bonus per un secondo viaggio, nel caso il primo non vada a buon fine e, in alcuni casi, il costo del trasporto, può essere, totalmente o parzialmente, pagato dall'immigrato svolgendo un servizio illecito (es. corriere di droga) per conto dei trafficanti.
(34) Il furto di clandestini, di cui il Comitato è venuto a conoscenza dagli inquirenti triestini, può essere di due tipi: diretto, quando gli immigrati vengono rapiti da criminali che, dopo un periodo trascorso all'interno delle organizzazioni di trafficanti, ne sono fuoriusciti ed hanno sfruttato il know how criminale per fondare un proprio sodalizio criminale; indiretto, quando i trafficanti che hanno curato il viaggio dei clandestini sino a quel momento, vengono arrestati dalle forze dell'ordine. A questo punto, lasciati allo sbando, gli immigrati vengono catturati da altre organizzazioni criminali, che esigono dai clandestini un determinato compenso, che incrementa sensibilmente il debito che dovrà essere risarcito.
(35) Centri riconosciuti e riconoscibili di transito e di organizzazione dei flussi migratori illegali sono le città di Budapest (Ungheria), Lubiana (Slovenia), Belgrado (Serbia) e Valona (Albania).
(36) Cfr. Resoconto stenografico dell'audizione svolta il 16 marzo 2000 al Comitato di lavoro sulla criminalità organizzata internazionale dal dottor Nicola Maria Pace e altri, cit., pg. 19.
(37) Cfr. P. L. Vigna, relazione al convegno Traffico di esseri umani. Alla ricerca di nuove strategie di intervento, Roma, 24-25 ottobre 2000, pg. 2.; Resoconto stenografico dell'audizione svolta il 24 febbraio al Comitato di lavoro sulla criminalità organizzata internazionale dal dottor Cataldo Motta, cit., pg. 6.
(38) Cfr. Resoconto stenografico dell'audizione svolta il 16 marzo 2000 al Comitato di lavoro sulla criminalità organizzata internazionale del dottor Nicola Maria Pace e altri, cit., pg. 12.
(39) Cfr. Resoconto stenografico dell'audizione svolta il 24 febbraio 2000 al Comitato di lavoro sulla criminalità organizzata internazionale dal dottor Cataldo Motta, cit., pg. 13.
(40) Cfr. Direzione investigativa antimafia, Il pericolo albanese, Roma, ottobre 2000, pg. 22 (Doc. 2178); Direzione investigativa antimafia, Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Secondo semestre 1997, Roma, 1998, pg. 26.
(41) Cfr. P. L. Vigna, La criminalità di matrice straniera in Italia, in Camera dei deputati - Senato della Repubblica, Le nuove mafie in Italia, cit., pg. 30. In relazione al rapporto tra camorra e immigrazione clandestina, cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, Relazione sulla lotta alla criminalità organizzata in Campania, approvata dalla Commissione il 24 ottobre 2000, relatore senatore Luigi Lombardi Satriani, XIII legislatura, Doc. XXIII, n. 46, pg. 58. Sul tema della criminalità organizzata in Campania, nella XIII legislatura sono state presentate alla Commissione due relazioni di minoranza, una da parte del senatore Emiddio Novi (Doc. XXIII, n. 46-bis) e un'altra dal senatore Michele Florino (Doc. XXIII, n. 46-ter).
(42) Cfr. Dipartimento per gli affari sociali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, cit., pg. 9.
(43) Cfr. K. Bales, I nuovi schiavi, cit.
(44) I trafficanti necessitano di personale addetto al trasporto (scafisti, autisti, staffette, meccanici), di personale in grado di procurare ovvero di fabbricare documenti falsi (burocrati, diplomatici, falsari), di personale in grado di gestire i capitali (commercialisti, consulenti finanziari), di personale che conosce adeguatamente le diverse legislazioni sull'immigrazione vigenti nei paesi di origine, transito e destinazione (avvocati, giuristi).
(45) Il verificarsi di eventi bellici (es. le guerre nei Balcani) o l'inasprirsi di azioni di persecuzione per motivi di razza, religione e opinione politica (es. i Curdi) sono principalmente alla base dell'aumento dei flussi migratori, così come l'annuncio dell'attuazione di un provvedimento di sanatoria all'interno di un paese sviluppato.
(46) L'efficace azione investigativa e di contrasto svolta dalla polizia giudiziaria e dalla Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Trieste hanno spinto i trafficanti a spostare i punti di ingresso dei clandestini verso la provincia di Udine e di Gorizia. Allo stesso modo, l'importante azione di contrasto svolta dagli inquirenti leccesi, unitamente all'aumento del controllo sulle coste pugliesi in seguito allo svolgimento della «Operazione Primavera», hanno spostato i punti di sbarco verso le coste ioniche e verso le coste dell'alto Adriatico.
(47) Cfr. A. Golini - I. Menichini, L'emigrazione italiana all'estero e la demografia dell'immigrazione straniera in Italia, in G. Zincone (a cura di), Primo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia, Il Mulino, Bologna, 2000, pg. 121, in cui si ricorda come dal 1876 al 1987 ventisette milioni di italiani sono espatriati verso altri paesi europei (oltre 14 milioni) e il 44% verso le Americhe (6 milioni al nord e 5 milioni al Sud).
(48) Cfr. Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale, Roma, 2000. I dati forniti mettono in evidenza come dal 1991 al 1999, gli stranieri respinti alla frontiera perché in possesso di documenti e/o visti falsi è passato da 660 a 3.658 (+ 454%).
(49) Ministero dell'Interno, Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata. Anno 1996, XIII legislatura, Doc. XXXVIII-bis, n. 2, Roma, 1997, pg. 459.
(50) Uno dei casi che, nel giugno di quest'anno, ha colpito l'opinione pubblica e gli investigatori è stata la scoperta, di 58 cittadini cinesi morti asfissiati in un camion olandese, al porto di Dover.
Cfr. Resoconto stenografico dell'audizione svolta il 17 ottobre 2000 al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'Unità Nazionale Europol (c.d. Comitato Schengen), dal Prefetto Gianni De Gennaro, Capo della Polizia, pg. 5, in cui si afferma che durante il 2000, nei porti di Ancona, Bari, Brindisi e Trieste, sono stati rintracciati 2.811 stranieri, imbarcati su navi regolarmente viaggianti e provenienti dai porti di Patrasso e Ygoumenitsa.
(51) Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Trieste, Contrasto alla criminalità transfrontaliera. Immigrazione clandestina etnica, luglio 2000, pg. 4 (doc. 2038/1).
(52) Cfr. Testimonianza di FODOR Tomo, uno dei principali complici di LONCARIC Josip, contenuta in: Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Trieste, (Doc. 2038.2), cit., pg. 35.
(53) N. M. Pace, I flussi migratori illegali, cit., nota n. 8.
(54) Cfr. N. M. Pace, I flussi migratori illegali, cit., nota n. 8; Resoconto stenografico dell'audizione svolta il 16 marzo 2000 al Comitato di lavoro sulla criminalità organizzata internazionale dal dottor Nicola Maria Pace e altri, cit., pg. 17.
(55) Cfr. Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Trieste, Contrasto alla criminalità transfrontaliera. Immigrazione clandestina dalla Cina e dal Bangladesh. Trasporti di clandestini via mare, settembre 2000.
(56) Cfr. Questura di Lecce, cit. (Doc, 1851.2), pg. 5.
(57) Nei mesi di febbraio - marzo e agosto 1991 nei porti di Otranto, San Foca, Brindisi e Bari sono attraccate sei motonavi e un mercantile che hanno trasportato più di 20.000 immigrati albanesi.
(58) Cfr. Resoconto stenografico dell'audizione svolta il 19 gennaio 2000 al Comitato di lavoro sulla criminalità organizzata internazionale, dal dottor Nicola Simone, Capo della missione interforze della Polizia italiana in Albania, pg. 6; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, Richiesta di ordinanza di custodia cautelare nei confronti di DE MITRI Alberto + 25, 30 aprile 1994, più nota come Operazione Caronte (Doc. 915).
(59) Cfr. Resoconto stenografico dell'audizione svolta a Durazzo l'8 novembre 2000 alla Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica dai responsabili della Missione Interforze di Polizia.
(60) Cfr. Ministero dell'Interno, Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata. Anno 1995, Roma, 1996, pg. 332, in cui si ricordano gli arresti, effettuati a Lecce, di Li Wiei Xian, capo della triade del Drago Verde (12 aprile 1995), e del boss turco Ismail Budak, responsabile di un'organizzazione criminale dedita al traffico di clandestini verso la Francia e la Germania (19 aprile 1995).
(61) Cfr. C. Motta, Immigrazione e criminalità, cit., pg. 48.
(62) Ultimamente si è notato uno spostamento verso le coste ioniche salentine, preferite in quanto meno controllate e comode agli sbarchi in quanto basse e sabbiose.
(63) Cfr. Resoconto stenografico dell'audizione svolta il 19 gennaio 2000 al Comitato di lavoro sulla criminalità organizzata internazionale, dal dottor Nicola Simone, in cui è stato riferito come i gommoni partono attualmente soprattutto dalle coste a nord o a sud del golfo di Valona.
(64) Cfr. La Gazzetta del Mezzogiorno, 22 ottobre 2000.
(65) Cfr. Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i servizi antidroga, Traffico internazionale di stupefacenti ad opera di gruppi albanesi presenti in Italia, Roma, Aprile 1999; Procura della Repubblica di Lecce, Dati per la provincia di Lecce, settembre 2000, in cui si riportano i dati dei sequestri di eroina, cocaina e cannabis indica, effettuati dal 1996 al settembre 2000. Le cifre riportate evidenziano come nel 1996 siano stati sequestrati Kg. 16,3 di eroina, Kg. 1,7 di cocaina e Kg. 3.000 di cannabis. Di quest'ultimo tipo di droga, nel 1997, la quantità sequestrata è stata pari a Kg. 13.000. Al 30 settembre 2000, i dati sui sequestri evidenziano significativi aumenti sia per quanto riguarda l'eroina (Kg. 28 sequestrati), che la cocaina (Kg. 12 sequestrati).
(66) Resoconto stenografico dell'audizione svolta il 24 febbraio al Comitato di lavoro sulla criminalità organizzata internazionale dal dottor Cataldo Motta, cit., pg. 3.
(67) C. Motta, Sul fenomeno della criminalità degli stranieri nell'ambito del distretto di Lecce, febbraio 2000 (Doc. 1780).
(68) Cfr. A. Pansa, cit., pg. 5.
(69) Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, Richiesta di rinvio a giudizio e Richiesta di custodia cautelare nei confronti di ZERVOUDAKIS Eftychios + 12, dicembre 1998.
(70) L'armatore è rappresentato da una società liberiana, la Claremont Shipping, presieduta da Mandhir Kumar Wahi, conosciuto come «Pablo» e indagato in India assieme al padre, Satpal Wahi, soprannominato «Daddy». La società ha uffici nel Pireo, in India e in Pakistan e gode di complicità di funzionari doganali di vari paesi (Egitto, Turchia, Cipro, Grecia, Malta, Siria).
(71) Ai dati del 1999 e del 2000 vanno aggiunti gli immigrati curdi provenienti dall'Iraq, dall'Iran e dalla Turchia.
(72) Cfr. Resoconto stenografico dell'audizione svolta il 16 marzo 2000 al Comitato di lavoro sulla criminalità organizzata internazionale dal dottor Nicola Maria Pace e altri, cit., pg. 3.
(73) In relazione a questa constatazione cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, Relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Calabria, approvata dalla Commissione il 26 luglio 2000, relatore senatore Michele Figurelli, XIII legislatura, Doc. XXIII, n. 42, pg. 188-191.
(74) Cfr. Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Migrazioni e sicurezza in Italia, cit., pg. 1108
(75) Cfr. I. Kennedy - P. Nicotri, Lucciole nere. Le prostitute nigeriane si raccontano, Kaos, Milano, 1999.
(76) In alcuni casi vengono utilizzati i convogli ferroviari, compresi quelli adibiti al trasporto delle merci.
(77) Cfr. Procura della Repubblica di Lecce, Dati per la provincia di Lecce, novembre 2000. I dati forniti indicano come gli arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nel distretto giudiziario siano stati 91 nel 1998, 256 (di cui 147 scafisti) nel 1999 e 123 (di cui 46 scafisti) al 30 settembre 2000.
(78) I dati forniti dal Ministero dell'Interno per l'anno 1999 non sono disaggregati come per il 2000, tra veicoli e natanti sequestrati. Le cifre attestano soltanto che nel 1999 sono stati sequestrati 198 mezzi in Puglia, 6 in Calabria e 37 in Sicilia.
(79) Cfr. E. Moroli - R. Sibona, Schiave d'occidente, Mursia, Milano, 1999.
(80) Cfr. Ministero dell'Interno, Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata. Anno 1996, Roma, 1997, pg. 347.
(81) Cfr. G. Zincone (a cura di), cit., pg. 59.
(82) Cfr. Ministero dell'Interno, Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia e sullo stato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica nel territorio nazionale, Anno 1998, Roma, 1999, Vol. Io, pg. 36, in cui si rammenta che nel corso dell'anno in esame sono state presentate 2.086 denunce all'Autorità giudiziaria per intermediazione abusiva di manodopera.
(83) Cfr. G. Zincone (a cura di), cit., pg. 66.
(84) Cfr. Ministero dell'Interno, Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata. Anno 1995, Atti parlamentari, Doc. XXXVIII-bis , N. 1, Roma, 1996, pg. 360.
(85) Cfr. M. Da Pra Pocchiesa, Ragazze di vita. Viaggio nel mondo della prostituzione, Editori Riuniti, Roma, 1996.
(86) Cfr. Commissione Affari sociali, Aspetti sociali e sanitari della prostituzione, Indagini conoscitive e documentazioni legislative, n.22, Atti parlamentari, XIII legislatura, Roma, 1999.
(87) Cfr. Direzione nazionale antimafia, Risposte delle Procure della Repubblica alla circolare PNA n. 8516/G/99, in data 5/6/98, cit., pg. 2.
(88) I dati sono tratti da: AA.VV, Annuario Sociale 1999, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1999 e dal materiale distribuito alla conferenza stampa sulla presentazione del numero verde contro la tratta delle donne organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimenti per gli Affari Sociali e per le Pari opportunità il 26 luglio 2000, a Roma.
(89) Cfr. Nato, HQ KFOR, Multinational Specialized Unit, Regiment HQ, Marylin Monroe Prostitution, N. 5/83. Pristina, Kosovo, 19 ottobre 2000.
(90) Il Comitato ha avuto modo di acquisire importanti informazioni relative alle modalità di sfruttamento di giovani donne da avviare alla prostituzione dal Comando Regione Carabinieri Basilicata, che ha inviato alla Commissione il documento intitolato: Fenomeno dell'immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù finalizzato allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro minorile nel territorio della Regione Basilicata. Attività di contrasto dell'Arma, Potenza, 3 dicembre 2000.
(91) Cfr. A. Bradanini, Il traffico degli esseri umani nella prospettiva delle Nazioni Unite, cit., pg. 3.
(92) Cfr. Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Migrazioni e sicurezza in Italia, cit. pg. 1153.
(93) Cfr. Resoconto stenografico dell'audizione al Comitato di lavoro sulla criminalità organizzata internazionale del dottor F. Frezza, cit., pg. 26.
(94) Comando Regione Carabinieri Basilicata, cit., pg. 2.
(95) Resoconto stenografico dell'audizione svolta il 16 marzo 2000 al Comitato di lavoro sulla criminalità organizzata internazionale dal dottor Nicola Maria Pace e altri, cit., pg. 20.
(96) Cfr. Resoconto stenografico dell'audizione svolta il 19 settembre 2000 al plenum della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, dal dottor Piero Luigi Vigna, cit., pg. 11.
(97) Cfr. M. Maddalena, La prostituzione e il suo sfruttamento da parte della criminalità. Il traffico degli esseri umani, in Senato della Repubblica - Camera dei deputati, Roma, 1999, cit., pg. 56-57, in cui si mette in evidenza come la maggior parte dei criminali stranieri implicati nello sfruttamento della prostituzione e nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina utilizzino una serie infinita di alias, minaccino le vittime che hanno denunciato unitamente ai testimoni, così come i familiari che si trovano nel paese d'origine.
(98) Le inchieste giudiziarie svolte in Italia, hanno accertato come le grandi distanze, le differenti lingue, la segmentazione su più livelli che contraddistingue il mercato criminale del traffico degli esseri umani, sono fattori che impongono ai capi delle organizzazioni etniche di mantenere e gestire i contatti tra di loro, e con quelli delle organizzazioni minori, esclusivamente per via telefonica, attraverso l'utilizzo di una lingua franca, come ad esempio l'italiano o l'inglese.
Questa mancanza di autosufficienza, nella specifica gestione delle attività inerenti lo smuggling e il trafficking, può considerarsi come un tallone d'Achille per il crimine transnazionale, in quanto rompe la compattezza della criminalità etnica e consente una maggiore capacità di penetrazione investigativa determinata anche dall'assenza ovvero dalla drastica riduzione dei problemi legati alla traduzione di una lingua straniera nella lingua italiana.
Le intercettazioni telefoniche, nel contrasto all'attività criminale del traffico degli esseri umani, si sono dimostrate uno strumento altamente efficace per una serie di ragioni, tra le quali:
 |
 |